|
RELAZIONI
Peter
KAMMERER
Mario
AGOSTINELLI
Wolfgang
SACHS
INTERVENTI
Fiorella
GHILARDOTTI
Vincenzo
VOLPI
Marina
SALAMON
Giancarlo
CERRUTI
Andrea
POGGIO
Lidia
MENAPACE
******************
Il
ponte
della
Lombardia
periodico
di commento
critica
progetto
Editore
Comedit
2000
Presidente
Paolo
Pinardi
Direttore
resp.
Luigi
Lusenti
Redazione
L.
Bellina, E. Cavicchini
A. Celadin,
A. Corbeletti
G.
Falabrino, L. Miani
A.
Ripamonti, F. Rancati
Direzione
e Amministr.
Via delle
Leghe, 5
20127
Milano
Tel.
02/28.22.415
Fax
02/28.22.423
ilponte@galactica.it
Reg.
Trib. MI n.
304 maggio 1992 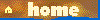
|
|
WOLFGANG
SACHS
Mi sembra che Agostinelli non abbia tralasciato nessuna tematica nella sua
introduzione, che mette un po' in alto mare un relatore che segue dopo. Io
vorrei cominciare con una storiella, quella mia preferita quando si parla
del tempo, storiella che e' presa da un racconto di Henrich Boll che parla
di un turista che fa una passeggiata alla spiaggia e incontra un pescatore
che e' li' sdraiato accanto alla sua barca e dorme. Il turista tira fuori
la sua macchina fotografica, scatta una foto, il pescatore si sveglia, e
il turista gli chiede: "Ah! Perche' sei sdraiato li'? Il tempo e'
bellissimo, c'e' tanto pesce, perche' non vai a pescare?" "Sai,
questa mattina ho gia' pescato abbastanza". "Vedi, tu potresti
adesso pescare tre-quattro volte al giorno, potresti fare soldi, dopo un
anno potresti comprarti una barca a motore, poi due barche e forse dopo
tre-quattro anni tutta una flotta e poi forse un elicottero per seguire
meglio i pesci, poi forse un camion per portare tutto questo pesce per la
distribuzione alla capitale. E poi... " "E poi?" chiede il
pescatore, "potresti prendere tutto il tempo per andare in spiaggia a
prendere il sole, l'oceano e' bellissimo". "Ah!", dice il
pescatore, "e' proprio quello che stavo facendo quando tu mi hai
svegliato scattando la fotografia!". Io lascio cosi' questa
storiella, mi sembra che pure nel tempo della compressione del tempo e
dello spazio questa storiella abbia ancora qualcosa da dire. Vorrei
parlare di cinque aree di discussione e di battaglia negli anni a venire,
perche' giustamente Mario ha fatto cenno al fatto che questa compressione
dello spazio e del tempo e' un'altra parola per questo grande processo in
atto della globalizzazione, che e' molto di piu' di una globalizzazione
solo economica. Infatti, come lui ha detto, il tempo perde la sua durata e
lo spazio perde la distanza. Posso farvi un esempio. Stento a crederlo,
pero' due fonti mi hanno riportato che, dopo le diciotto di sera, gli
annunci che vengono fatti dalla Lufhtansa all'altoparlante dell'aeroporto
di Taeghel a Berlino vengono pronunciati in California. Vuol dire che l'annunciatore
verso sera non e' nell'edificio, neanche a Berlino, e' in California e
segue tutti i processi, l'andamento dell'aeroporto attraverso il piccolo
schermo e fa gli annunci, per sfruttare cosi' 24 ore su 24. Non devi
pagare il compenso di chi lavora di notte per Berlino. Quindi li' c'e' la
contemporaneita' e c'e' la sparizione della distanza e la sparizione della
durata. Nell'ombra di questa nuova era, che puo' solo essere comparata a
quella di quando siamo andati dalle economie locali alle economie
nazionali, adesso si va dalle economie nazionali a un'economia
transnazionale, quindi l'idea che la societa' sia un contenitore mi sembra
stia scomparendo, la societa' non e' il contenitore, che e' ben
delimitato. In questo contesto vorrei utilizzare alcune delle tematiche
sviluppate nel mio libro, dando un po' il filo conduttore, chiedendomi
quali sarebbero le arene di discussione, quali sarebbero anche i lati
deboli della globalizzazione, della globalizzazione economica in primo
luogo e anche di quella culturale. Mi focalizzo sui lati deboli perche'
non dimentichiate mai che, oggi come oggi, coloro che sono piu' nervosi
dei sindacalisti sono i capitalisti. Quindi attenzione, la globalizzazione
e' un'avventura ad altissimo rischio per qualsiasi imprenditore, per
qualsiasi investitore; esistono incertezze, lati deboli o, se volete,
questi lati deboli possono essere trasformati in zone contestate, in
territori di conflitti: per questo voglio focalizzare cinque domande che i
capitalisti devono porsi, domande sulle quali noi poi, se volete, potremo
intervenire facendo presente una concezione diversa della societa' e del
progresso. Faccio queste cinque domande delle quali la prima e': per
ciascun imprenditore, come vincere? La seconda domanda: cosa fare con i
perdenti? La terza domanda: come entrare nel territorio? La quarta: come
mantenere accelerata la gente? La quinta: come assicurare un volume
crescente di domanda? Io vorrei parlare di queste cinque "zone
contestate". La prima: come vincere? In questa era di globalizzazione,
visto che ci sono molti piu' competitori, la domanda "con quale
ricetta puoi vincere sul mercato" e' una domanda molto grande. Tutto
diventa piu' flessibile sotto l'imperativo di cambiamento; qual e' la
prospettiva di innovazione in un mondo di incertezza? Su quale cavallo
scommettere? E li' c'e' oggi, piu' che nel passato, un discorso su cosa
fare anche nell'azienda, quali prodotti, quali innovazioni per quali
bisogni proporre. E li', come voi sapete, quello che e' importante per me
che sono ambientalista - e forse anche per un dibattito e una controversia
- e' che i vari limiti della biosfera saranno sempre piu' condizione-guida
dei processi di domani. Quindi un punto di entrata e' come sara' possibile
premere, fare dell'ecologia una dimensione integrale della produzione. Per
fare questo pero' certo bisogna abbandonare questa utopia del
diciannovesimo secolo, che diceva che la produzione puo' sempre contare
sulla generosita' della natura, sull'abbondanza quasi infinita della
natura. E cosi' si e' messo in moto negli ultimi cento anni un progresso
tecnico che ha messo tutta l'enfasi sull'aumento della produttivita' del
lavoro, dimenticando il fatto che tanta di questa produttivita' si e'
guadagnata dal danneggiamento della natura, quindi alle spese della
stessa. Questa utopia dell'abbondanza della natura oggi e' crollata con la
famosa situazione econologica, cosi' l'utopia cambia colore e la domanda,
quando si discute del futuro dei prodotti e dei processi, e': "e'
possibile dare un indirizzo diverso al progresso tecnologico"? Certo
che e' possibile, bisogna cambiare questa logica della produttivita',
mettere meno enfasi sull'aumento della produttivita' di lavoro, e metterne
molta di piu' sull'aumento della produttivita' della natura, su una
maggiore efficienza, che vuol dire in modo molto piu' convenzionale
disegnare tecnologie che utilizzino meno energia e meno materiali per
unita' di output. Come si puo' ricavare piu' benessere da un litro di
petrolio, da una tonnellata di rame? In altri termini, non sarebbe meglio
avere un progresso tecnologico che licenzia migliaia di tonnellate di
acqua, migliaia di tonnellate di rame invece che migliaia di persone? Un
progresso tecnologico che punta molto piu' sulla ecoefficienza? Per questo
ci vuole certo anche una nuova visione imprenditoriale, ci vogliono anche
dei parametri come ecotasse, pero' di questo adesso non ne parlo. Volevo
scendere maggiormente nei dettagli ed evidenziare tre linee sulle quali si
puo' andare avanti in questa ricerca di una maggiore ecoefficienza. - La
prima linea e' la produzione di materiali che siano biodegradabili. Alcuni
istituti di ricerca oggi sostengono che e' fattibile la produzione di
tanti prodotti del nostro uso quotidiano sulla base di materiali
biodegradabili. E' proprio necessario che nelle suole delle scarpe ci
siano materiali pesanti? O per le fibre tessili; mi ricordo che una volta
sono stato a una presentazione dove in una discussione del genere il
relatore aveva un pezzo di stoffa per il divano e ha cominciato a mangiare
questo pezzo di stoffa per dimostrare che il materiale proveniva da
risorse biologiche. Per dare un altro esempio sei mesi fa Greenpeace in
Inghilterra ha fatto un contratto con una grande banca inglese per l'introduzione
della carta di credito biodegradabile fatta di un materiale plastico
ottenuto dalla biomassa e che quindi puo' ritornare alla terra. Cosi' vale
per tanti prodotti, forse non in un immediato futuro, ma la strada e' senz'altro
percorribile. - La seconda strada per procedere e' una strada un po'
diversa; riguarda i prodotti durevoli, non quelli d'uso quotidiano;
parliamo della macchina, della lavatrice, del computer. Qual ' e' l'imperativo
centrale? Certo e' la durevolezza. Allora come e' possibile fare prodotti
che durino a lungo, che siano costruiti in modo da poter essere smontati,
che abbiano dei moduli interscambiabili? Cio' e' possibile attraverso l'introduzione
di un nuovo principio, quello della responsabilita' sistemica. Vuol dire
che il prodotto - ad esempio un frigorifero - non esce mai dalla
proprieta' del producente. Quando io vado in un negozio per comprare un
frigorifero, l'affitto o faccio un leasing del frigorifero e non lo
compro, la proprieta' non diventa mia. Perche'? Il motivo e' chiaro? In
tal modo, dopo dieci anni, quando voglio liberarmi del mio frigorifero,
questo viene restituito alla casa di produzione e non viene gettato o
abbandonato, come e' in uso in qualche paese. Ci sono gia' esempi di
questo genere; mi sembra, questo, un principio importantissimo per
cambiare a monte il disegno dei prodotti. - La terza strada da seguire e'
quella che in generale si puo' mettere sotto il titolo Dal prodotto al
servizio; molto spesso invece di produrre qualcosa, qualche artefatto, e'
meglio chiedersi quale servizio vuole la gente. Voi conoscete questa
discussione sull'energia, la gente non vuole l'energia nucleare, la gente
vuole riscaldare il caffe', qual e' il metodo migliore per riscaldare il
caffe'? Questo e' il problema, non vendere elettricita'. La Ranx Xerox,
per fare un esempio, e' incentivata a vendere macchine fotocopiatrici che
durano, perche' loro non guadagnano vendendo tante macchine, mettono un
servizio che e' attento alla manutenzione delle macchine e poi sono
incentivati a fare un re-engineering delle macchine dopo che sono usate.
Quindi spostare l'attenzione dalla espansione dell'offerta al servizio,
cambia il mondo degli artefatti, cambia il mondo della produzione. Queste
sono tre grandi strade: biodegradabilita', responsabilita' sistemica,
prodotti-servizi, su cui si puo' mandare avanti la discussione su quale
cavallo scommettere, cosa saranno i prodotti e i processi di domani.
Procedo con la mia seconda arena di discussione, e questo lo faccio in
modo un po' piu' sintetico. Il lato debole per la globalizzazione riguarda
senz'altro cosa fare con i perdenti. Mai dimenticare che la
globalizzazione e' un gioco per individuare i vincitori, cosi' per
definizione ci saranno un sacco di perdenti. E' anche chiaro che la
globalizzazione significa che abbiamo bisogno di sempre meno gente per
produrre la ricchezza della societa', in un certo senso crescera' il
numero della gente superflua, pero' un'azienda puo' permettersi di avere
gente superflua, perche' puo' licenziarla. Una societa' non puo'
permetterselo, non puo' permettersi di avere gente superflua, perche'
questo a medio termine creera' un sacco di problemi. Quindi da questo
punto di vista come voi sapete bene, sorgono queste domande che voi avete
discusso sulle 35 ore e cosi' via; e' chiaro che non avremo mai piu' la
piena occupazione, anzi, e' anche chiaro che non abbiamo mai avuto la
piena occupazione, perche' la piena occupazione era sempre solo maschile e
la meta' del mondo era sempre esclusa. Quindi oggi si sovrappongono queste
due cose; la societa' non offre piu' lavoro e molte piu' persone, incluse
le donne, chiedono lavoro e da qui l'insorgenza di difficolta'. Si puo'
rispondere solo come voi dite sempre: certo ridurre il lavoro per ciascuno
per distribuire il lavoro a tutti e' il principio importantissimo. A che
scopo, pero'? Per ridefinire e ripensare le attivita' utili nella societa'.
Diventa di nuovo visibile che il lavoro remunerato non e' il solo tipo di
attivita' utile che c'e', ci sono almeno tre compartimenti di attivita';
da un lato c'e' il lavoro retribuito, poi c'e' l'attivita' di sussistenza,
di autoproduzione, infine c'e' l'impegno civile. Nell'ambito di queste tre
sfere di attivita' utile, se uno parla di una redistribuzione del lavoro
remunerato, significa dare piu' spazio a questi altri tipi di lavoro,e
quindi una distribuzione piu' equa del lavoro remunerato. E' anche chiaro
poi che se non tutti possono avere lavoro sorge un altro problema: finora
la distribuzione della ricchezza e' stata fatta mediante l'occupazione.
Quindi se non tutti hanno piu' occupazione, uno deve inventarsi altre
forme di ricchezza, e qui c'entra anche la discussione sul reddito di base
garantito. Si apre di conseguenza la discussione su come organizzare e
reinventare anche il tempo fuori dal lavoro remunerato, i discorsi sulle
banche del tempo, su nuove forme di scambio e cosi' via. Io vorrei solo
dire che in questa prospettiva oggi c'e' la possibilita' di congiungere l'utile
al necessario; c'e' oggi la necessita' della flessibilizzazione da parte
del capitale, questo e' chiaro. E' possibile raggiungere questa necessita'
con l'utile, vuol dire desiderio di tanti per una maggiore sovranita' sul
tempo da parte di individui. Questo mi sembra oggi l'altro grande punto di
intervento. Vengo alla mia terza zona contestata: come entrare nei
territori. E' vero, come ha detto Mario Agostinelli, che questa
riorganizzazione del tempo e dello spazio rende vagabondo il capitale; ma
questo capitale vagabondo che circola, ad un certo punto deve atterrare.
Ecco, ci siamo noi sul territorio. Non c'e' dubbio che anche il capitale
vagabondo deve cercare un porto, deve insediarsi, deve fare delle cose,
deve fare una produzione o deve anche vendere le cose, quindi deve
localizzarsi. Certo i luoghi sono posti della gente, sono posti della vita
quotidiana, i territori sono i posti dove spuntano i conflitti, perche'
poi certo si apre la domanda: "a quali condizioni"? Come e'
possibile che il capitale vagabondo si insedi con le sue esigenze nel mio
territorio? Tanti conflitti sociali che oggi ci sono dappertutto nel mondo
possono essere letti in questa chiave.In questa ottica mi sembra anche
interessante tutta la discussione su quanto aperta deve essere una regione
per il mercato mondiale, per quanto dipendente o indipendente dal mercato
mondiale. Mi sembra che oggi si sospetti sempre piu' che l'economia
planetaria non e' piu' un'utopia incontestata, mostra sempre piu' i suoi
lati oscuri. Questo e' chiaro per due motivi: la democrazia e l'ecologia.
Per la democrazia e' tutto vero, si deve sempre dire in Padania che e'
vero, la democrazia puo' essere soffocata attraverso l'auto-isolamento,
attraverso la fortezza; pero' d'altro canto e' anche vero che la
democrazia puo' essere soffiata via attraverso troppa autoesposizione,
attraverso una societa' che diventa nuda e senza protezione verso le forze
dell'esterno. La sovranita' e' democrazia e democrazia vuol dire gestire
le cose nostre, la democrazia richiede uno spazio di sovranita',
altrimenti l'idea delle cose nostre perde senso. In questo senso certo la
globalizzazione e' in grande contrapposizione all'idea della democrazia;
visto che il pianeta non puo' diventare la polis, se vogliamo mantenerla
dobbiamo inventarci qualcosa. Quello che pero' e' piu' importante secondo
me e' l'ecologia. E' chiaro che maggiori interconnessioni significano
trasporti, trasporti, trasporti. Se le distanze tra produttore e
consumatore crescono (scarpe dal Taiwan, fiori dal Kenya), e' chiaro che i
trasporti crescono; anzi si puo' dire che tanti dei guadagni della
produttivita' delle nuove tecnologie vengono fatte spostando le cose dall'interno
dell'azienda all'esterno di essa. Per questo anche lo spazio virtuale e il
tempo reale richiedono poi un trasporto fisico delle cose, sia di persone
che di beni. Quindi cosi' non e' un caso che per esempio produzioni just
in time hanno portato a un aumento di traffico dappertutto in Europa, che
in un certo senso il management porta al fact transportation. Quindi cosi'
il guadagno di tempo e' apparente, e' una redistribuzione del tempo, in un
certo senso va fatto alle spalle del territorio, alle spalle di quello che
poi devono muovere. Anche il territorio e' sottoposto sempre piu' all'imperativo
di diventare permeabile, transitabile. Pensate al ponte sullo Stretto,
alle gallerie della Svizzera o sul Brennero, alle autostrade che devono
essere prolungate, al tunnel sotto la Manica e cosi' via. E' la pressione
a rendere transitabile lo spazio, lo spazio e il territorio, che e' pero'
uno spazio di vita, dove la gente vive, pero' e' sempre sottoposto alla
presunzione di trasformarsi in uno spazio di transizione. E' chiaro che
anche dal punto di vista ecologico diventa importante far prevalere contro
questa visione l'idea di un'economia piu' regionalizzata. Comunque credo
che la scala geografica delle operazioni economiche diventi sempre piu'
una tematica importante. Gia' oggi le imprese locali, piccole e medie,
sono superiori nella creazione di lavoro, nella prestazione di qualita' di
servizi, sono superiori per quanto riguarda la restituzione dei crediti e
cosi' via. E aggiungerei dell'altro: a lungo termine e' chiaro che il
livello regionale, per esempio, e' molto importante per creare un'economia
di manutenzione e riparazione, per mantenere e riparare i beni che devono
durare a lungo, pensate al principio della responsabilita' sistemica di
cui ho parlato prima. Certo e' necessaria un'industria di servizio di
manutenzione e di riparazione locale e regionale, perche' questa industria
deve essere vicina al consumatore. In una prospettiva piu' lunga, un'economia
solare potrebbe per forza essere un'economia regionalizzata. Perche'? Per
un motivo semplice: i fondi dell'energia solare sono dappertutto, il sole
cade in modo molto diffuso, non in modo concentrato, quindi vale la pena
di raccogliere il sole in modo disperso e utilizzare questa energia in
modo molto decentralizzato, per la natura intrinseca di questa fonte
energetica. Lo stesso principio vale per la biomassa. La biomassa e' una
delle grandi risorse del futuro, non e' concentrata come il carbone, anzi
e' diffusa attraverso il territorio, quindi vale la pena di raccoglierla e
poi di utilizzarla in modo diffuso, perche' non vale la pena trasportarne
delle tonnellate. La prospettiva dell'utilizzo dell'energia solare nel
futuro mi sembra che stia prefigurandosi come nuova forza di un'economia
regionale, l'idea di un'economia confederata potrebbe guadagnare anche
terreno. Questo mi porta alla quarta arena di discussione sulla
globalizzazione: come mantenere la gente accelerata. Se uno vuole portare
avanti una tendenza sovversiva e' importante rompere con questa utopia che
le velocita' piu' elevate sono sempre preferibili alle velocita'
contenute. Per cento-centocinquant'anni abbiamo cercato di avanzare il
piu' possibile nel piu' breve tempo, e cosi' si e' creata una societa'
irrequieta, destinata oggi a fare un nuovo salto. Vorrei offrire alcune
osservazioni che potrebbero man mano diminuire questo entusiasmo per la
velocita', portando avanti un certo sentimento sovversivo che anche la
lentezza potrebbe avere qualche pregio, che il rallentare potrebbe avere
una qualita' interna e questa qualita' del rallentare e' anche un modo per
portare la protesta contro la pressione della globalizzazione nella vita
quotidiana. Basta guardare le automobili, e' chiaro che le automobili sono
la tecnologia quotidiana che ha cercato di incorporare l'ideale della
velocita', e cosi' ci vengono offerte macchine con valori di accelerazione
e velocita' di punta, come se dovessimo ogni giorno sostenere una gara
sulle autostrade. Ma un'auto di fatto trascorre l'80% del suo tempo nel
traffico cittadino e le velocita' medie si aggirano attorno a 15-20 km
orari! Quindi mettere automobili ad alta prestazione sulle strade di
citta' oggi e' altrettanto razionale come tagliare il burro con la
motosega. Questa convulsione per la velocita' ci ha dato una flotta
automobilistica che e' grottescamente ipermotorizzata, con tutto lo spreco
di energia e materiali che ne consegue. Non c'e' bisogno di un'ecologista
per capire il divario tra il mezzo e l'uso che ne viene fatto, a parte il
fatto che, se l'automobile e' una cosa che deve correre, corre solo un'ora
su ventiquattro e quindi diventa piu' chiara l'irrazionalita' intrinseca
in queste tecnologie di velocita'. Riprendo un'altra cosa che ha detto
Mario: abbiamo fatto le nostre esperienze con le macchine per il risparmio
di tempo, anzi ne siamo circondati: l'automobile, il fax, l'e-mail, tutte
in un certo senso sono macchine per farci risparmiare tempo; pero' dove e'
finito il tempo guadagnato? Siamo alla ricerca del tempo guadagnato, cosa
e' successo? Che al contrario oggi ci troviamo in situazioni di
nervosismo, di stress continuo. Perche'? Vale la pena prendere ad esempio
l'automobile: paradossalmente la gente che possiede una macchina non
trascorre meno tempo per la mobilita' e per il trasporto, rispetto a
coloro che non la possiedono. Quindi la gente che viaggia in automobile
non utilizza meno tempo per gli spostamenti. Cosa e' successo? E' chiaro,
quelli che acquistano una macchina viaggiano di piu'; quindi il tempo
risparmiato viene tradotto in distanze piu' lunghe. Cosi' noi oggi
viaggiamo molto piu' della gente di solo dieci, venti, trent'anni fa,
pero' in gran parte per le stesse destinazioni, per gli stessi scopi:
lavoro, scuola, medico e cosi' via. La stessa cosa avviene anche con l'e-mail.
Voi sapete che l'e-mail oggi e' gia' un grande canale di intasamento e che
il Times Magazine aveva una notizia sei mesi fa sull'e-mail che tutti
usano, e questo e' il problema. Se uno riceve 50, 80 e-mail al giorno la
cosa diventa impossibile, il sistema crolla. E questo succede gia' in
California oggi, cosi' adesso la Microsoft offre Intelligent Agents, un
software che permette di installare corsie preferenziali per sistemare i
messaggi e-mail che arrivano, che vengono smistati su corsie lente e su
corsie preferenziali. Quindi oggi si ha sulle "superstrade dell'informazione"
lo stesso problema che si aveva prima sulle superstrade vere! Quello che
voglio dire e' che noi trasformiamo tutti i risparmi del tempo per nuove
distanze, per maggior output e per un maggior numero di attivita'; le ore
risparmiate vengono tradotte in nuova crescita, se noi traducessimo le ore
risparmiate in meno lavoro, in meno spostamento, in questo senso avremmo
una situazione piu' liberata, pero' noi scegliamo di tradurle in nuova
crescita. Certo questa accelerazione mostra sempre piu' il suo lato
oscuro; oltre a una certa soglia l'accelerazione mostra una tendenza
controproducente, si arriva sempre piu' velocemente in luoghi dove poi si
resta sempre meno. Tanta energia viene investita in arrivo e in partenza,
ma poca in presenza. Quindi l'incontro perde sempre piu' importanza e cio'
diventa maggiormente chiaro quando uno e' alla ricerca di una migliore
qualita' di vita, alla ricerca di prestare piu' attenzione alla situazione
presente, e allora si comincia automaticamente a rallentare, perche' la
precisione di dedicarsi a una situazione richiede di seguire i ritmi
intrinseci di questa situazione, richiede di dare l'addio all'accelerazione
imposta. Ebbene, tutto questo si potrebbe anche tradurre in progetto
tecnologico, noi per esempio in questo libro abbiamo proposto una flotta
automobilistica solo moderatamente motorizzata, perche' e' chiaro che
anche tutta questa accelerazione costa un sacco di energia, con l'accelerazione
cresce quasi esponenzialmente il consumo di energia e quindi se uno vuole
arrivare a una societa' piu' leggera deve per forza cercare di stabilire
un livello intermedio di velocita'. Io credo che l'utopia del prossimo
secolo sara' di inventare tecnologie che ci permettano di vivere con
eleganza all'interno dei limiti. Questo mi porta al mio ultimo punto: come
assicurare un maggior volume di domanda. Anche li' si apre la questione
del tempo, perche' - e questo e' il guaio della societa' consumistica -
oltre a una certa quantita' gli oggetti diventano ladri di tempo. Come ha
raccontato un antropologo sui Navajos, che vivono al sud-ovest negli Stati
Uniti, una famiglia navajos possiede in media 236 oggetti, una famiglia
tedesca in media ne possiede 10mila. Vanno benissimo 10mila oggetti
piccoli e grandi, pero' bisogna scegliere, comprare, disporli,
utilizzarli, pulirli, spolverarli, ripararli e cosi' via. Anche gli
appuntamenti che abbiamo oggi devono essere presi, concordati,
monitorizzati. Sia gli oggetti che gli eventi sono un richiamo al nostro
tempo e il nostro tempo, in modo conservatore, ha sempre solo 24 ore! A
forza di spingere sempre piu' oggetti e appuntamenti in questo tempo
limitato diventiamo nervosi, stressati. Quindi la scarsita' del tempo e'
diventata la dea vendicatrice della ricchezza; in altri termini noi si',
siamo ricchi di beni, ma poveri di tempo. Questo si puo' anche dire in
modo molto piu' preciso, perche' se guardate la soddisfazione che deriva
dai beni essa consiste di due cose: c'e' sempre una soddisfazione esterna
e una soddisfazione interna. Se voi comprate cose per la cena, poi
cucinate e riempite il vostro stomaco, questa e' soddisfazione esterna; se
a voi piace mangiare alla maniera turca e fare una cosa conviviale con gli
amici, questa e' una soddisfazione immateriale, una soddisfazione interna.
Allora cosi' e' sempre, la soddisfazione richiede sempre un'attivita'
interna, uno sforzo di coltivare qualcosa, di gustare meglio, di celebrare
qualcosa. Qui si apre il dilemma: i tanti beni possono entrare in
conflitto con la voglia di una soddisfazione completa. In altri termini la
soddisfazione esterna e quella interna non possono essere massimizzate
allo stesso tempo. Se volete ottimizzare il vostro consumo, ottimizzare la
vostra soddisfazione, dovete per forza limitare la soddisfazione esterna
o, in altri termini, la sobrieta' deve diventare un ingrediente necessario
per il benessere. Paradossalmente, la capacita' di dire di no, una certa
austerita', diventano pre-condizioni per il benessere, altrimenti ci
succede come a Horowat, che e' un autore austro-ungherese che ha fatto una
battuta - e con questo concludo - dicendo: "Ah! In fondo io sono una
persona totalmente diversa, ma non ho mai il tempo di esserlo".
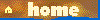

|