|
Il
Pietro
Ingrao
Uno
dei pregi di questo libro è che, con una scrittura asciutta e limpida e
con grande forza comunicativa, pone questioni enormi, che partono dalla
riflessione sulla crisi di quel soggetto collettivo che ha trascinato e
orientato tanti di noi, dentro le battaglie di questo secolo.
Zipponi
segnala con molta forza quella mutazione che chiamiamo per comodità
post fordista, indica i saperi con cui dalla sponda del capitale questa
mutazione è stata messa in campo; e coglie il nuovo approdo, che non
appartiene più al mondo della fantascienza, ma comincia ad essere
qualcosa di reale, con cui dobbiamo misurarci: parlo della dilatazione
del macchinismo, della macchina che, correndo, si spinge, o viene
spinta, sempre più a sostituire l’uomo. E’ questa, al fondo, la
grande questione del Novecento.
E
dobbiamo riconoscere che,
su questa base, nel giro degli ultimi venticinque anni l’avversario,
il capitale, ha spostato e rimodellato quel panorama sociale, già
sconvolgente, che si era prodotto all’inizio
del secolo e che abbiamo simboleggiato con l’impresa fordista.
Ci abbiamo messo molto per capirlo e per leggere il cammino del fordismo
che, rimodulando la vita di questo paese, nel suo rivoluzionamento
aggregava e in qualche modo unificava il soggetto lavorativo, la massa
dei lavoratori, la quale, per dirla con un’immagine, conosceva così
somiglianze e concentrazione. Ma è stato questo il punto di leva per le
battaglie che sono venute.
Oggi
ci troviamo di fronte ad una mutazione che sconvolge questo sistema di
aggregazione e tende a frantumare e ridislocare, secondo la sua logica,
la grande massa della forza lavoro, dei lavori salariati .
Qui
sta la grandezza e la drammaticità dell’evento, e qui sta anche la
nostra sconfitta.
Sconfitta
che, non lo possiamo dimenticare, noi, la sinistra, abbiamo subito
proprio sul tema che più avevamo fatto nostro, quello del lavoro
salariato.
Non
sono sicuro che noi, intendo in questo caso la sinistra sindacale,
abbiamo sottolineato con abbastanza forza la drammaticità di questo
evento, prodottosi alla fine del secolo, evento che ha portato il
rapporto fra capitale e soggetto lavorativo a manifestarsi in forme
cariche di una formidabile capacità di inclusione.
La
dimensione assunta da questo processo ci richiama adesso a riportare il
nostro discorso e la nostra riflessione al grande tema del ruolo dello
Stato, o meglio del ruolo di ciò che è pubblico; e a seguire con
grande attenzione le novità che si manifestano nei processi in corso
A
Nizza i sindacati erano presenti in massa e anche la stampa borghese ha
colto la radicalità dell’evento. Dopo Maastricht, per la seconda
volta, vediamo così riemergere e ridisegnarsi scenari, forme ed attori
di una soggettività e di
un agire politico.
Ho sempre provato diffidenza rispetto
alla teoria, che ha avuto grande seguito, della “scomparsa della
politica”. In realtà mi
sembra che ci troviamo di fronte alla riconferma impressionante di un
agire politico: senza accorgercene abbiamo discusso di una carta
costituente dell’Europa e dei fondamenti costitutivi di una dimensione
sovranazionale. Non so come andrà a finire, ma a a Nizza abbiamo
assistito ad una articolazione di storie e rappresentanze nazionali. E
non è poca cosa vedere riemergere entità nazionali in questo quadro
chiaramente europeo e sovrannazionale;
e sentire che parole come Francia, Germania, Italia,
apparentemente superate, sono tornate
a confermare, quale soggetto politico,
lo stato nazionale.
Per
tornare alla questione centrale, ci troviamo quindi di fronte, dopo
quella fordista, ad una
seconda rivoluzione e al rapido innesto della mutazione politica nei
processi sociali e nella
stessa questione sociale.
Su
questo terreno incontriamo naturalmente la forza penetrante
dell’avversario, ma anche le contraddizioni drammatiche che è venuto
sollevando.
E
che riguardano l’invenzione dei nuovi saperi (che dobbiamo cercare di
classificare bene) e,
insieme, l’attacco, non
solo alla dimensione lavorativa ed alla forza lavoro, ma alla vita e
all’esistere, ossia il dilatarsi dell’iniziativa capitalistica
all’insieme del processo vitale.
Nel
libro c’è, non a caso, un forte ancoraggio al tema del tempo, inteso
non solo come quantità di ore libere, cioè come confronto tra ore di
lavoro e ore di non lavoro,
ma come attenzione ai momenti
feriti della vita.
Da
questa riflessione prende avvio il ragionamento intorno agli infortuni
sul lavoro, e, di fronte a quei dati impressionanti, sorge spontanea una
considerazione: ma come, la mutazione che ci ha messi in ginocchio, che
ha ridisegnato il mondo, che ha prodotto saperi, alla fine approda a
questo? Sono così sapienti
e così incapaci di garantire
la vita, la salute, la sicurezza in
senso materiale?
A
ben vedere, nell’epoca dei saperi il tema degli infortuni sul lavoro
sembra rimandare all’inizio del secolo o prima ancora,
all’ottocento. Si tratta di un segnale sconvolgente e ci dice che i
momenti della vita feriti dalla radicale mutazione, non stanno solo
dentro la fabbrica, ma escono dai suoi confini.
Zipponi,
cogliendo questo tema, argomenta
una risposta del lavoratore, del proletario: “il mio tempo non ti
appartiene”.
.Di
fronte ad una velocizzazione su scala mondiale, alla dilatazione del
momento produttivo nelle altre sfere della vita, ad una mutazione a
livello globale della misura e della caratteristica del tempo, ecco riemergere la
grande questione dell’uso e dei contenuti del tempo
Da
questo ragionamento dovrebbe scaturire, nuovamente e con forza, la rivendicazione di una riduzione dell'orario di lavoro: ma non saremo in grado di
dare risposte positive alle questioni del tempo ed alle sue
implicazioni, se ci limiteremo ad una lettura chiusamente economica
dell’atto lavorativo, e quindi a una riflessione puramente
quantitativa sull’orario. Bisogna invece dilatare il discorso sul
tempo di lavoro, ma anche, e di più, sul tempo di vita
Viviamo,
è vero, in un'epoca di oscuramento della questione lavorativa, ma
allora dobbiamo porci alcune domande. Fino a dove, questo oscuramento si
spinge? Fino a toccare le condizioni di vita. Che confini ha il
conflitto sul tempo? Non è solo riposo, è di più;
è tutto ciò che sta dentro la sfera del "non lavoro",
e che aveva trovato nel corso della civiltà umana scansioni e sanzioni,
che venivano da una spinta religiosa: la questione della domenica, del
giorno del non lavoro, che non era tempo
vuoto ed assenza, ma era il giorno del “sacro”. Non sono
credente, ma mi appare chiaro quale valore assumesse, allora, il momento
del riposo rispetto a quello del lavoro, e come il mondo del lavoro si
trovasse poi ad incontrarsi con un mondo di non lavoro, che non era un
vuoto, ma un pieno.
Per
questo non sono convinto di come sia stato abbandonato il tema del
lavoro notturno, con l'enorme significato che il mondo del notturno
porta con sé. "Chi lavora di notte, poi recupera le ore di
sonno", ci dicono. Ma dormire significa entrare in un'altra soglia,
come ci ha spiegato la grande cultura del Novecento:
e questo non lo puoi trasporre, perché non solo significa non
avere la possibilità di stare nello stesso letto con la propria moglie,
o con il proprio bambino, ma coinvolge tutta l’enorme questione del
“notturno”, come ci hanno spiegato non solo Freud, ma altri grandi
autori, come Kafka.
E
allora, se dobbiamo affrontare la questione del tempo e della sua
riappropriazione, dobbiamo rendere più chiare le sue implicazioni ed il
legame con i contenuti del tempo di non lavoro, che riguardano lo stare
in comunità, la fede, la passione estetica, l’amore: perché anche
questo ci viene tolto.
Se
accettiamo questo punto di vista allora
dobbiamo affrontare la questione di cosa è il non produrre.
Ho
scritto dei versi sull’alta febbre del fare e non ho trovato molto
ascolto, anche perché alludevo ad un altro fare.
Nel
libro si sviluppano ragionamenti interessanti sul telelavoro che, qui
sta il paradosso, non produce tempo libero ma, viceversa, si traduce in
assenza di orario e quindi, dilatando all'infinito il momento
lavorativo, in assenza di libertà.
Ma
se vogliamo affrontare questi aspetti dobbiamo cogliere la complessità
dell’accaduto e le implicazioni della rivoluzione che si è compiuta.
Se il tempo della vita personale, degli affetti e dei
divertimenti, è diventato un polmone a disposizione dell’azienda, è
necessario ragionare sulla vita delle persone sia in termini
quantitativi che qualitativi.
Cosa
è, ad esempio, il lavoro a chiamata? E’, a suo modo, una forma di
schiavitù. E allora dobbiamo includere nella nostra valutazione anche
l’autonomia personale, la specificità individuale ed il suo progetto.
Perché fuori dal momento produttivo la differenza dell’individuo
torna con una forza che non possiamo dimenticare e quindi entra in gioco
il rapporto tra società lavorativa ed individuo.
Solo
se ci porteremo su queste sponde saremo
in grado di elaborare una risposta.
Il
processo sconvolgente della sostituzione dell’uomo da parte della
macchina, ma anche della riduzione dell’uomo a macchina vitale, è
emersa con chiarezza nella vertenza alla Zanussi, dove anche il
sindacato ha condotto una battaglia, per dimostrare come quella
proposta, che riguardava l’orario di lavoro, avesse un contenuto
eversivo; e come l’affitto delle persone rischia di diventare
l’affitto delle possibilità di progetto.
Noi,
contro questo tentativo di riduzione della persona a macchina vitale,
dobbiamo far intervenire un altro tipo di calcolo, un’altra scala di
valori, altrimenti saremo sconfitti.
Questo
comporta valorizzare appieno il tempo di vita, non solo come riposo, ma
come tempo creativo. Non restauro per il lavoro, non parentesi per la
vita vera, che sarebbe nel
lavoro. Anche la canzone famosa, che pure ho cantato molte volte, “noi
vivremo del lavoro o pugnando si morrà”, oggi mi persuade fino ad un
certo punto.
In
questo ragionamento anche la formazione deve essere, certo, formazione
e riqualificazione per il lavoro, ma anche possibilità di
fruizione di altro.
Il
fare ha molte facce, si fa anche non facendo, e quindi dobbiamo
estendere l’idea dell’agire umano e dell’esperienza umana fino a
valorizzare il “non fare” e fino a comprendere ed a misurarci con le
sfere del sonno, del sogno, del gironzolare, del contemplare. Su questo
terreno abbiamo subito l’espropriazione più grande, addirittura
simbolica: l’espropriazione della notte. E
noi, sinistra e sindacato, abbiamo ceduto su quel nodo, senza
grandi clamori.
Di
cosa hanno paura i lavoratori se portano avanti un discorso di questo
genere? Di essere considerati sfaticati?
Nel
libro si cita un segretario dei metalmeccanici che negli anni ’70 a
proposito delle 150 ore disse “i lavoratori hanno diritto ad avere una
cultura generale, anche se poi dovessero utilizzarla per suonare il
clavicembalo”. E' molto bella questa frase che, sintenticamente, dice
quello che ho espresso finora.
Voglio
aggiungere un’ultima considerazione critica: vedo nel sindacato un
deficit di memoria storica. Oggi, contrariamente a quanto è avvenuto in
passato, alla sfida posta dalle nuove forme educative e dai moderni
strumenti di comunicazione (in qualche modo il maestro e il prete che
entrano in camera da letto) il sindacato non sembra in grado di
rispondere con strumenti adeguati.
Di
fronte a mutazioni di portata trascinante, mi colpisce il fatto che non
si discute, non si spendono
risorse; mi colpisce che il sindacato, insomma, abbia perduto quel gusto
dell’egemonia, che pure, in alcune fasi, lo portò ad avere posizioni
più avanzate, rispetto ai partiti storici della sinistra
Fuori dalla volontà e dalla capacità
di intervento su questi diversi terreni, ci dicono le ultimissime pagine
del libro, c’è la deriva corporativa nei luoghi di lavoro, vale a
dire la caduta dei grandi progetti e della riflessione sull'uomo, che
sono stati essenziali per far crescere quello straordinario sindacato
che oggi è in crisi.
*******
“Ci
siamo!”
Milano,
giovedì 12 ottobre, ore 20.00: la legge di Murphi (“se qualcosa può
andare storto, sicuramente lo farà”) non è un’invenzione.
Sciopero
dei mezzi; acqua a catinelle; semafori in tilt; agli incroci, grovigli
d’auto inestricabili, sulle strade, code inamovibili; i vigili, una
razza estinta.
Insomma,
la serata adatta per dire “Ci siamo!”.
Nonostante
tutto, e incredibilmente, alla sala Di Vittorio della Camera del Lavoro
cinquecento persone hanno assistito alla presentazione del libro di
Maurizio Zipponi “Ci siamo! Operai, impiegati, precari nella nuova
economia” (copertina rossa, ingranaggio grigio con punto esclamativo
al centro, che evoca la pubblicistica degli anni delle grandi lotte
operaie).
E
se Rossana Rossanda, Cesare Salvi, Fausto Bertinotti, Mario Agostinelli,
si sono presi la briga di discutere del mondo del lavoro, delle sue
trasformazioni, e di sinistre; se tanta gente ha deciso di uscire dei
casa per ascoltarli, allora, non solo il lavoro non è finito (e chi lo
teorizza dice le bugie) ma c'è molto da fare.
I
testi non sono stati rivisti dagli autori
Rossana
Rossanda
Nell’enorme
quantità di testi sul lavoro e sulla fine del lavoro, questo piccolo
libro ha il pregio, non solo di essere scritto con semplicità e
chiarezza, ma di essere scritto da qualcuno che, regolarmente, accompagna
le tesi e le idee che avanza con quel che ha visto e ha vissuto,
all’Ansaldo Energia di Legnano, piuttosto che alla Marelli di Corbetta,
dando (cosa che i sociologi non fanno) la percezione
immediata di cosa è stato in questi anni e cos'è oggi una lotta
all'interno del mondo del lavoro.
Sono
dell'idea che i libri vadano comprati, letti, diffusi: tanto più questo,
che va completamente ed efficacemente contro il senso comune diffuso nella
cultura sociologica e politica dominante, secondo la quale siamo alla fine
del lavoro, o perlomeno grazie al progresso tecnologico, ad una riduzione
esponenziale del lavoro dipendente ed alla possibilità di un lavoro che,
affrancandosi dallo sfruttamento, si trasforma nella categoria un po’
confusa (sulla quale Zipponi fa chiarezza) del lavoro autonomo. In ogni
caso, non saremmo più in una fase un cui sono esigibili i diritti del
lavoro sui quali tutto il dopoguerra, non solo italiano, ha basato e
sviluppato la propria esistenza politica.
La
mia generazione, ad esempio, è cresciuta nella percezione che ci fosse,
oltre ai partiti politici, una presenza sociale dominata, sostanzialmente,
da una proprietà capitalistica sempre meno agricola e sempre più
industriale e, dall’altra parte, da quella che veniva chiamata classe
operaia, la classe lavoratrice che ingaggiava battaglie per la democrazia,
per i diritti e il valore del lavoro, per il salario. Molti ricorderanno
la lunga fase di dure lotte, che è poi sfociata nel periodo compreso tra
il '67 ed i primi anni '70, nel corso del quale il soggetto del lavoro
acquisisce anche una forte coscienza.
Un
grande suggeritore della politica italiana oltre che governatore della
Banca d’Italia, Guido Carli, sostenne allora che le ragioni
dell’impossibilità di una crescita e di un ammodernamento forte
dell’industria e della produzione italiana stavano proprio nella forte
conflittualità sociale, nella
crescita della domanda e dei bisogni che veniva dal mondo del lavoro e che il conflitto acceso che
aveva investito gli operai (in una convergenza con gli studenti), era la
causa dell’impossibilità di rinnovamento del sistema politico. Carli,
nel 1977, diceva con chiarezza quello che oggi sentiamo ripetere
continuamente: che la crescita dell’economia nel nostro Paese è
ritardata dai lacci e lacciuoli costituiti da un lavoro
"rigido", cioè con
troppi diritti. Intendendo per diritti il tempo di lavoro indeterminato,
la non licenziabilità senza giusta causa (confermata dal recente
referendum), una quota sul salario enormemente cresciuta alla fine degli
anni ’60, un sistema normativo che difende e privilegia il lavoro in
rapporto alle leggi obiettive della crescita economia.
La
tesi di Carli viene usata oggi non solo da Confindustria ma diffusa dai
mezzi di informazione di massa e sostenuta anche in libri di sociologi
sulla fine del lavoro.
La
richiesta, in nome di una presunta obiettività delle leggi dello sviluppo
economico, è che il lavoro diventi una merce soggetta soltanto alla
contrattazione di mercato, non abbia quelle che vengono chiamate rigidità
ma sono i suoi diritti. In questo modo il mercato, con la sua mano
invisibile (è una vecchia storia), avrebbe una funzione di equilibrio,
anche attraverso tensioni e conflitti,
e il risultato finale sarebbe una crescita dell’economia e quindi
un aumento dell’occupazione, del lavoro, del benessere.
Questa
è la tesi generale contro la quale si pronuncia con molta chiarezza e
sulla base dell’esperienza il libro di Zipponi. Nega che oggi non ci sia
più spazio al contratto tra le due parti, contesta il fatto che esista un
solo bene in sé: la produzione economica con i suoi meccanismi per cui il
padronato ha il diritto di ridurre tutte le forme del conflitto e della
contrattazione. Questa tesi viene denunciata in "Ci siamo!" come
tipicamente ideologica, così come è considerata “falsa coscienza” la
teoria secondo cui il mercato può equilibrare di per sé nel suo gioco
l’insieme delle forze sociali; e, soprattutto, è da combattere l'idea
che si è venuta rafforzando all’interno delle forze della sinistra,
delle organizzazioni sindacali ed anche nel senso comune, che così è,
che non si può fare nulla di diverso.
Naturalmente
la critica de sindacalista Zipponi alla sinistra è non solo di aver
rinunciato ad una prospettiva di superamento del sistema capitalistico, ma
anche di essere progressivamente arretrata di fronte alla necessità di
una contrattazione che rifiuti di considerare il lavoro come una qualsiasi
merce, ed all'idea che
compito dello Stato e del sistema politico sia quello, nella dialettica
delle parti sociali, di difendere e sostenere come interesse comune i
diritti del lavoro organizzato.
Questa
è la tesi del libro, che poi si precisa con una serie di dati e di
esperienze dalle quali emerge quanto sia falsa la teoria della fine del
lavoro: su scala mondiale assistiamo ad una
"messa al lavoro" di dimensioni inedite per la produzione
di profitti, di quantità e specificità umane non soltanto operaie; e,
anche da noi, il lavoro dipendente (che è lavoro tipicamente sfruttato)
non è diminuito.
Accanto
al lavoro dipendente si sta sviluppando una forma di lavoro atipico
assolutamente congeniale alla volontà del
padronato, per cui il lavoratore, senza una difesa legiferata e
organizzata, è solo di fronte all’impresa.
In
questa grandiosa messa al lavoro e al profitto del mondo,
aumenta, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, il tempo
sottratto alla persona, al lavoratore, fino alla richiesta della sua
totale disponibilità all'impresa (il lavoro a chiamata proposto alla
Zanussi è esemplare da questo punto di vista).
C’è
una devastazione dell’idea del lavoro, in presenza di un potenziale
soggetto sociale planetario che, come è accaduto per lo schiavismo e
dovrebbe succedere per la mercificazione del corpo, potrebbe portare
avanti un'idea di società in cui il lavoro umano sia
qualcosa di non riducibile a sola merce.
La
tesi di Zipponi (ed io condivido questa idea) è che siamo di fronte ad
una aggressione ad uno dei diritti fondamentali della modernità
e che bisogna invertire la tendenza.
E
qui si tocca un tema che interessa direttamente la sinistra e la Cgil.
Di fronte all'operazione globale di impossessamento del corpo e
dell’anima dei lavoratori ai fini dell’impresa e del profitto, si pone
una domanda: la collettività politica, la sfera politica, la sinistra,
deve intervenire o fare
propria la tesi che il mercato decide di tutto e che quindi
l’istituzione pubblica, la sfera statale non deve intervenire in questo
meccanismo virtuoso?
Zipponi
non si nasconde che nel corso dell’ultimo decennio la sinistra ha
rinunciato alla tesi secondo cui il lavoro è un soggetto sociale
indisponibile.
Il
1989 non solo ha annullato l'idea che si dovesse spezzare il sistema
capitalistico, ma ha distrutto anche l’ipotesi che si dovesse
contrattare il lavoro, cioè la tesi socialdemocratica per cui la sinistra
può (anzi deve) rinunciare all’abbattimento del sistema, però deve
contrattare e difendere i diritti del lavoro.
In
questo cambiamento che forse è ancora in corso, Zipponi vede anche la
crisi, il distacco crescente dell’opinione pubblica e dei lavoratori dal
sindacato e dai partiti politici, fino all’astensionismo, cosa non
abituale in un paese come il nostro dove la partecipazione al voto è
stata sempre molto alta.
Così
il distacco dalla politica si trasforma in un clima diffuso di
antipolitica, anticamera della destra.
Il
mutamento dell’idea di società e lo scomparire della necessità, della
legittimità di una dialettica sociale, allentando il rapporto di fiducia
tra i lavoratori e la loro organizzazione, mette in crisi il sindacato.
La
tesi più netta avanzata nel libro è che l’annullamento dei diritti del
lavoro dequalifica il complesso della produzione, mentre una reale
dialettica sindacale spingerebbe l’impresa ad una maggiore qualità
della produzione e che, quindi, l'annullamento del conflitto faccia male
all’insieme della società, mentre il rilancio di una forte azione
politico sindacale sul lavoro ed i suoi diritti sia fondamentale per lo
sviluppo. Quindi, conclude Zipponi, è necessario un nuovo compromesso,
nel senso di una regolazione dei rapporti di forza tra i due
soggetti sociali in campo.
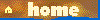

Cesare
Salvi
Questo
libro nasce da una esigenza che chi, come molti di noi, è ancora mosso da
una passione politica e sociale, avverte in questo periodo: sono visibili
i segni di una sconfitta, di un arretramento, e ci si pone il problema di
come reagire, non rassegnarsi o non illudersi che i meccanismi della
politica spettacolo, più o meno efficaci, siano una forma di reazione
adeguata.
Il
problema è più profondo e non
si risolve semplicemente studiando meccanismi comunicativi (cosa che pure
conta), o scegliendo candidati particolarmente abili nelle apparizioni
televisive.
C’è
qualcosa di più rilevante se tutta la sinistra, quella al governo e
quella che negli ultimi due anni è stata all’opposizione, ha perso
dalle elezioni del ’95 –
’96 ad oggi circa quattro milioni di voti (tanti sono, infatti, gli
elettori che nel ’95 o nel ’96 votarono PDS o Partito della
Rifondazione Comunista e che alle recenti elezioni europee e regionali non
hanno votato a sinistra), così come sono reali ed evidenti
le difficoltà di rappresentanza politica dei partiti della
sinistra e quelle di rappresentanza sociale del sindacato.
E
allora il nodo di fondo è analizzare i problemi, i percorsi, i processi
in corso e vedere quali risposte sono state date e quali eluse.
Spesso
non si è compreso ciò che sta accadendo nella società italiana, nel
mondo del lavoro, a cominciare dal fatto che esiste un problema di lavoro
dipendente. Spesso si sono date risposte che colpiscono negativamente,
lasciano il segno e fanno intendere come non si sia colta la portata dei
problemi: il discorso sulla fine del posto fisso ad esempio, quante
incomprensioni, che messaggio negativo ha di fatto trasmesso, al di là
delle intenzioni di chi lo proponeva. E, soprattutto, c’è una politica
della sinistra che non affronta i temi e le questioni vere.
“Ci
siamo” collega esperienze concrete, vissute, con tematiche più ampie e
complessive ed affronta i problemi reali del mondo del lavoro, ricercando
soluzioni e risposte positive. Dal mio osservatorio di Ministro del Lavoro
è utilissimo per capire molto più di quanto non appaia da una
rappresentazione mediatica che poi trascura la sostanza delle questioni.
Zipponi
non si lamenta perché il mondo cambia, non pensa che le vecchie
soluzioni, le vecchie risposte siano ancora valide; quindi è del tutto
estraneo all’accusa che, più
spesso a torto che a ragione, ma a volte a ragione, viene rivolta alla
sinistra, di essere conservatrice.
Qui
c’è un tentativo di individuare risposte nuove: il ragionamento sulla
formazione, sull’innovazione, la riflessione sul nodo del rapporto tra
tempo di lavoro e tempo di vita visto soprattutto come il tema su cui si
può e si deve costruire un nuovo compromesso
sociale. Un compromesso avanzato (questa è la proposta politica
finale) tra le esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori, che tenga
conto delle trasformazioni ma abbia il carattere di un compromesso vero
(cioè gestito socialmente, collettivamente, non individualmente) e,
questo è il punto cruciale, che abbia come oggetto l’organizzazione, la
ripartizione del rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Torna
più volte la consapevolezza che questo problema non si risolve con una
formula o con una legge una tantum, ma che ci sia una centralità che va
al di là anche delle specifiche soluzioni che vengono date.
Lo
diceva Rossanda (ma ce lo aveva già spiegato Marx): il contratto di
lavoro non è uguale agli altri contratti.
Nel
contratto di lavoro l’oggetto dello scambio è la
persona, la forza lavoro, si
tratta quindi di un contratto che qualitativamente
è ben diverso da quello che riguarda i beni o le merci esterne. Questa
considerazione conta ancora più del fatto, pure importante, che nel
contratto di lavoro le parti sono due, strutturalmente diverse, una più
forte, una più debole, che il rapporto è strutturalmente diseguale,
e che, quindi il contratto di lavoro non può essere assimilato ai
normali contratti di diritto privato che, viceversa, si basano sull’idea
della parità formale delle parti.
E’
un tema importante su cui la sinistra, come in molti altri campi, ha avuto
una difficoltà, una debolezza di riflessione e di capacità di risposta.
Torna
nell’idea di Berlusconi che propone il contratto individuale e libero;
torna nell’idea delle regolazioni di rapporti di lavoro come peso,
vincolo, come ostacolo; torna quando si tenta di cancellare quel complesso
di regole e diritti conquistati in decenni di impegno sociale, culturale e
di riflessione dei lavoratori, con una proposta che si presenta come
moderna ma che in realtà, come ricordava Rossana, è una soluzione che
esisteva cento anni fa, prima che si costruissero il diritto e le regole
del lavoro.
In
realtà il neoliberismo, forse l’ultima delle ideologie rimasta, è
anche la più vecchia perché ripropone in veste moderna soluzioni del
passato.
E
allora è importante che su questo ci sia una reazione, politica ma
soprattutto culturale e sociale,
che sappia costruire risposte alternative, diverse e più avanzate ai
problemi.
Zipponi
affronta il tema del precariato e delle tutele sociali e propone di farsi
carico in positivo del problema dei giovani che hanno un rapporto
di lavoro incerto,
temporaneo, interinale collegando a questa condizione lavorativa il
meccanismo della tutela minima di reddito, che non significa salario
sociale minimo e diffuso, perché avverte la necessità di separare la
logica del lavoro dalla logica dell’assistenza.
Mi
ha colpito, e non l’avevo trovata altrove, l’idea di
incardinare questa tematica su chi ha un lavoro temporaneo o
precario in vista della stabilizzazione del rapporto del lavoro.
Faccio
questo esempio per dire che c’è, e questo è importante per la sinistra
di oggi, la capacità di avanzare proposte nuove ai problemi.
Il
ragionamento e la proposta politica alla fine del libro parte (come si
dovrebbe più spesso fare) da una analisi della situazione, delle forze
sociali e degli orientamenti politici e culturali in campo.
Anzitutto
contrappone il modello sociale degli Stati Uniti con il modello sociale
europeo.
Il modello sociale statunitense, presentato sempre come modello
di riferimento, viene proposto come modello forte sulla base di una scelta
ideologica o culturale: quella che gli indicatori della qualità di un
paese siano alcuni e non altri, che gli indicatori di successo siano la
crescita del prodotto interno lordo, indici di occupazione svincolati
dalla qualità del lavoro che viene impiegato e così via. E’ una
premessa culturale e ideologica che deve essere resa esplicita, perché
non è detto che quegli indici debbano essere assunti da tutti.
Nel bellissimo libro “Sviluppo e libertà” Amartya Sen scrive: intanto capiamoci su cosa intendiamo per sviluppo,
perché da quello poi si arriva a ragionare su cosa intendiamo per libertà.
Si può intendere per sviluppo la crescita della ricchezza complessiva e
basta, ed è un punto di vista, non è oggettivo. Se alla crescita della
ricchezza si aggiungono altri indicatori come la coesione sociale, la
speranza di vita media della popolazione, le differenze, ecc. allora
emerge un’altra idea di sviluppo. Sulla base di quest’altra idea di
sviluppo i giudizi di valore sono diversi e anche la nozione di libertà
da tutelare cambia perché diventa più articolata (è un discorso che
consente anche di articolare teoricamente il rapporto tra libertà e
socialismo in modo meno semplicistico di come tante volte si sente fare
anche a sinistra in tempi recenti).
Il
modello sociale americano presenta certamente, se si guarda alla crescita
in termini di prodotto interno lordo indici estremamente avanzati; ma se
si assumono altri indicatori, anche numerici, di valutazione il giudizio
è completamente diverso.
Ha
ragione Zipponi: la percentuale della disoccupazione negli Stati Uniti è
bassa anche perché viene scomputato il dato della popolazione carceraria
che quest’anno ha superato i due milioni di persone; riportata alla
popolazione italiana, qui dovrebbe esserci mezzo milione di carcerati, cioè
nove volte quelli effettivi. Il
basso tasso di disoccupazione degli Stati Uniti è il prodotto di quel
tipo di modello sociale, anche perché la popolazione carceraria risponde
ad una esigenza di controllo sociale che riguarda prevalentemente, se non
quasi esclusivamente, giovani di colore delle aree urbane.
Questo
è l’esempio più vistoso, se ne potrebbero aggiungere altri, anche più
significativi: l’aspettativa di vita della popolazione americana è la
più bassa dei diciannove paesi più industrializzati dell’OCSE,
evidente conseguenza di un sistema estremamente ridotto e modesto di
welfare; ci sono poi l’indice di povertà, l’indice di analfabetismo
funzionale e così via.
Quindi
noi abbiamo in Europa un modello sociale che, sia pure con i suoi limiti,
le difficoltà, le carenze, assume (o ha assunto finora), almeno a livello
di principi, che non è poco, un punto di vista diverso, più ampio, più
complessivo di valori di riferimento.
Zipponi
si domanda: necessariamente in Europa bisogna passare dalla fase liberista
prima di avere la possibilità di riprendere un discorso di tipo sociale?
La
domanda è giusta ed io credo che la risposta debba essere con chiarezza:
no.
Non
solo per un giudizio di valore, ma anche per un giudizio legato a quelli
che sono oggi, anche in queste nostre nazioni ricche, se li si sa cogliere
e interpretare, i sentimenti diffusi in settori crescenti della
popolazione.
Fino
a non molto tempo fa, il neoliberismo ha avuto una sua forza egemonica
nell’indirizzare costumi, senso comune, orientamenti di fondo nelle
nazioni dell’Occidente avanzato, negli Stati Uniti, in Europa.
La
tendenza contro lo statalismo, la spesa pubblica, il burocratismo spingeva
settori diffusi di ceto medio a considerare le proposte che
articolavano il discorso “libertà” anche in campo economico, come
potenzialmente vincenti e fortemente maggioritarie. Questo processo ha
avuto conseguenze vistose.
Oggi
non è più così: c’è un senso diffuso e crescente di insicurezza,
miscela di fattori diversi, che può avere anche derive inquietanti di
tipo populistico. Si traduce in termini di ordine pubblico, nei casi
peggiori può rivolgersi verso l’estraneo, il diverso, ma è,
generalmente, un senso di insicurezza nelle prospettive di vita, nelle
protezioni sociali, nella conservazione del posto di lavoro, a proposito
dello slogan devastante “il posto fisso è finito”.
E
allora, il senso diffuso di insicurezza richiede un ritorno a protezioni,
a una logica solidaristica.
E’
un punto molto delicato da cogliere nella direzione giusta, del resto gli
stessi partiti della destra cercano di darsi ormai una copertura di questo
tipo.
Busch
aveva provato con la teoria del “conservatorismo compassionevole” ma
la netta scelta di Al Gore,
almeno nella fase iniziale della sua campagna elettorale, di difesa e
rilancio dello stato sociale lo ha messo in difficoltà.
I
conservatori inglesi hanno appena concluso il loro congresso dove, di
fronte agli errori anche devastanti commessi da Blair, hanno scelto un
taglio molto populista. Portiglio, il nuovo esponente nascente, ha parlato
in spagnolo, come apertura verso i lavoratori che vengono da fuori, e
tutti hanno citato le proprie origini, segno che c’è un terreno diverso
rispetto al passato sul quale si misura il confronto anche in termini di
consenso.
Lo
stesso esito del referendum danese, che ha detto no all’adesione alla
moneta unica, è stato legato alla preoccupazione che l’adesione alla
Unione Europea potesse significare progressivo smantellamento delle
protezioni sociali, in una logica, quindi, di difesa dello stato sociale
ed anche di una pressione fiscale elevata.
Da
noi Berlusconi sta iniziando a fare proprio questo, è evidente il senso
della sua campagna elettorale: alziamo le pensioni più basse.
Sullo sfondo si intravede il resto del programma, un programma
liberista classico: lo stato assistenziale per i poveri e poi libero
contratto, libertà individuali che si traducono in
libertà di licenziamento, privatizzazione del sistema
pensionistico e sanitario e così via.
Oggi
il problema per la sinistra è intervenire su questo aspetto con proposte
innovative, coraggiose, evitando l’ inquietante saldatura tra liberismo
e populismo.
Questo
è, infatti, il vero senso
del rapporto tra Forza e Lega: indirizzare il senso di insicurezza verso
l’altro, il diverso, e dentro la comunità degli inclusi c’è la
soluzione liberista.
Zipponi,
a conclusione del libro, dice: allora l’alternativa deve essere
costruita tra i veri liberali, cioè quelli che credono alle regole e al
diritto, e la sinistra di ispirazione socialista e comunista.
Credo
questa intuizione sia significativa ed abbia a che vedere anche con le
differenze che ho appena descritto tra modello sociale statunitense e
modello sociale europeo.
Certo,
è sempre più evidente che se non si parte dai problemi veri; se non si
riconoscono le difficoltà profonde in cui si trova la sinistra, che a
volte sembrano da tutti messe da parte; se non si riconosce la sconfitta;
se non si ammette che questa sconfitta
dipende da processi reali, strutturali che la sinistra non ha
saputo intercettare, non ha saputo capire, a cui non ha saputo dare
risposte; se con si comprendere che la risposta non sta
in meccanismi interni al sistema e al ceto politico, che pure hanno
una loro importanza (aggregazioni, leggi elettorali, ecc.) perché è
successo qualcosa di più
profondo; se non si capisce che i
problemi dell’oggi si affrontano analizzando cosa è successo e provando
a dare risposte innovative, e costruendo su questa base alleanze che
vadano anche oltre la sinistra ma che partano
dai problemi e da impostazioni culturali precise, questa situazione
non si recupererà in alcun
modo.
Per
questo penso che, forse, bisognerebbe fare un passo avanti rispetto alla
tesi, che spesso accetta comodamente sia il mio partito che quello di
Bertinotti, dell’esistenza
di due sinistre rispetto alle quali il massimo che si possa realizzare è
una sorta di non belligeranza finalizzata
alla riduzione del danno, che, temo, di danni non riuscirà a ridurne
molti.
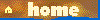 
Fausto
Bertinotti
Considero
il libro di Maurizio Zipponi un contributo utile anche metodologicamente.
L'ho letto con piacere perché sentendo più di lui il peso della
sconfitta generale, finalmente mi sono trovato di fronte a casi in cui si
vince, o almeno si è determinata una incidenza reale nei processi.
Zipponi,
però, non fa una operazione tranquillizzante: ha occhi per vedere,
orecchie per sentire e compie un’utile operazione nel momento in cui
porta il vissuto collettivo al confronto di una elaborazione. “Ci
siamo” è il contributo di un sindacalista e, spero si possa dire senza
retorica, è il contributo di esperienze operaie e impiegatizie, di un
soggetto che tende ad essere
cancellato anche nella sua possibilità di esprimersi.
Insomma,
questo lavoro mi pare un pezzo dell'inchiesta di cui abbiamo bisogno.
Provo
a dire tre cose sul libro, ed a questo mi atterrò, persino rifiutando la
suggestione di una polemica aperta con Salvi sulla questione della
sinistra.
Il
primo punto è una messa a fuoco dell'analisi dei processi di
ristrutturazione capitalistica, che sono un aspetto importante
dei più generali processi di ristrutturazione. Essi riguardano
l'economia mondiale, la globalizzazione, il rapporto tra capitale
collettivo e capitale finanziario, i processi di riorganizzazione più
generale del rapporto tra la produzione e il consumo, il mercato e lo
stato.
Zipponi
li analizza da due punti di vista distinti:
quello dell'impresa e quello dei lavoratori.
Quello
dell'impresa. Mi sembra giustissima la sottolineatura di Rossanda: il
libro è una replica sistematica, fondata sullo studio di casi, che rende
indicibile la teoria della fine del lavoro, e l’operazione conseguente
di ridimensionamento drastico del peso del lavoro anche nella percezione e
nella soggettività di chi lo vive, oltre che nella cultura e nella
politica.
Ciò
che giustamente viene messo in evidenza è il rapporto tra l'ideologia
(che tende a comprimere il lavoro) e le modificazioni strutturali, non
ineluttabili che, però, quando si producono, determinano
cambiamenti che alterano anche i rapporti di potere tra imprese e
lavoratori.
Le
imprese cambiano, e il libro prende in esame i processi di
esternalizzazione, non soltanto di attività facilmente separabili, ma di
parti strutturali e decisive nella catena di riorganizzazione del processo
produttivo e del processo di lavoro.
Si
vede chiaramente come
l'allargamento di questa catena determini fatti socialmente significativi,
sia sul versante dell'impresa che del lavoro subordinato e salariato, cioè
una diversa concentrazione del potere decisionale che, anche nella catena
delle imprese, viene dislocato in modo inedito in luoghi strategici sempre
più concentrati.
Grazie
alle intese e agli accordi internazionali e multinazionali le imprese
spostano il potere decisionale lontano dai luoghi dove viene organizzata
concretamente la produzione e il lavoro. Così si determina un processo di
frantumazione del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori e della loro
rappresentanza.
Questo
ultimo elemento non è accidentale, è parte organica di un processo di
ristrutturazione che ottimizza l'investimento per una redditività
immediata, o almeno a breve termine, mentre scompare dall'orizzonte delle
imprese l'investimento a redditività differita.
Questa
operazione dà ragione alla tesi di Rossanda circa i modi della
riorganizzazione del capitalismo italiano che accetta una divisione
internazionale del lavoro, lo colloca nei settori in cui la competizione
avviene sui bassi salari e sulla flessibilità, e quindi produce una
sollecitazione a relazioni
sociali e industriali in cui l’unico potere è quello dell'impresa.
Questa
struttura industriale non è innocente: questo è accaduto perché fa
parte di una idea, per noi pericolosa ma non stupida, che infatti ottiene
qualche risultato.
Qui
Zipponi affronta tre nodi politici che andrebbero approfonditi, su uno dei
quali dissento.
Non
concordo con la tesi ottimistica secondo cui la mancanza di conflitto
sociale fa male anche ai padroni e all'impresa. In assenza di conflitto
crescono i profitti, si riducono i salari e le imprese competono.
Non
è vera questa idea secondo cui i padroni che competono sui settori bassi
della produttività sono arretrati e quelli che competono sui settori alti
sono padroni avanzati.
Ciò
che Zipponi sostiene funzionava in una determinata condizione sociale,
quella del compromesso sociale tra la borghesia e il proletariato, che ha
realizzato lo stato sociale, il potere contrattuale dei lavoratori, i
contratti nazionali. In quella fase era vero che il conflitto costituiva
un elemento progressivo anche per l'impresa, che l'impresa aveva bisogno
del conflitto perché competeva in un quadro in cui il compromesso sociale
era l'elemento fondativo.
Ma oggi le imprese usano il lavoro come ventre molle su cui
premere e per quella via guadagnano una capacità competitiva: non hanno
bisogno della spia del conflitto sociale per
correggere e innovare; sono sfidati dalla competitività
all’innovazione, ad una innovazione interna al processo.
Infatti gli Stati Uniti, con il 35% degli occupati che vive sotto
la soglia di sussistenza, sono competitivi, realizzano all’interno del
continente uno scambio tra grandissime concentrazioni di investimenti,
alte qualità strategiche e aree totali di competizione del terzo mondo.
In
Italia, del resto, a un basso livello del conflitto, corrispondono alta
crescita del prodotto interno lordo e altissima crescita dei profitti.
Alcuni
punti su cui concordo.
Il
primo e più importante: anche in questa condizione tanto dannata si può
determinare un intervento operaio e sindacale che incide sui processi.
E’ il caso dell’Ansaldo citato nel libro.
Il
secondo. Zipponi dice: rispetto al modello di sviluppo e al modello
industriale il pallino deve tornare allo Stato.
Bisognerebbe
poi discutere di quale stato stiamo parlando, se basta la dimensione
nazionale o è necessaria una dimensione sovranazionale come quella
europea, che tipo di poteri, di intervento statale vanno messi in campo.
Resta
il fatto che, se non ricostruiamo una capacità di intervento dello stato,
del pubblico nell’economia, la possibilità per paesi come l’Italia di
scalare i livelli della divisione internazionale del lavoro e proporre un
diverso modello industriale dentro un diverso modello di sviluppo è
totalmente inesistente.
Anche
in quel caso il conflitto può incidere, può cambiare, ed è tantissimo,
la condizione di vita della gente, la condizione di un’impresa. Ma non
modifica la tendenza generale.
Il
lavoro. Il quadro che abbiamo di fronte è tale che occorre che le
sinistre (quelle che ci sono, due, tre, una sicuramente non è)
provino a partire da un serio bilancio della condizione lavorativa,
senza il quale è inutile qualunque discussione.
Prendendo
come spartiacque l’ottobre dell’80 e la sconfitta alla Fiat, la
domanda di fondo è: a che punto siamo su questioni che attengono alla
condizione lavorativa quali infortuni, salario, tempo? Oggi stiamo peggio
di ieri.
La
precarietà è oggi strutturale. Non si è precari perché non ancora
entrati nel mercato del lavoro stabile, si è precari perché il mercato
del lavoro prevede: una quota di lavoro relativamente stabile, una massa
di disoccupati e un’area crescente e pervasiva di precariato.
Così
il lavoro precario diventa elemento guida non perché è lavoro autonomo,
ma in quanto condizione moderna del lavoro, condizione del moderno
capitalismo. Il precario è in qualche misura quello che nel fordismo era
l’operaio alla catena di montaggio. E’ questa l’idea di fondo.
Hanno
vinto nell’80 alla Fiat e il processo di ristrutturazione che è seguito
ha messo sotto controllo la forza lavoro.
E
la citazione fatta da Rossanda di Guido Carli è azzeccata: sapete cosa
dovete fare, borghesi, o abdicate e ve ne andate, lasciando agli altri il
governo della società, oppure dovete mettere sotto controllo due prezzi,
quello della forza lavoro e quello delle materie prime.
Operazione
in larga misura riuscita
Come
si interviene su questo nodo? E, oltre al processo di ristrutturazione, ai
processi materiali e alla soggettività dell’avversario di classe,
abbiamo qualche responsabilità anche noi?
E’
mia opinione che, dopo la sconfitta, sia intervenuta la complicità di un
sindacato che sostanzialmente è diventato parte di governo di questi
processi.
Non
sto parlando di tradimento, sto dicendo che c’è stata la progressiva
assunzione di un altro punto di vista; è scomparsa la visione non di
Marx, ma di Max Weber, secondo cui in fabbrica, nel processo produttivo i
soggetti sono due: l’uno è il padrone e l’altro il lavoratore.
E’
questa idea che si è alienata, e il sindacato ha tendenzialmente assunto
un punto di vista neutrale, cioè subalterno, sui processi di
ristrutturazione, scegliendo precisamente la strada che la Fiat ci propose
nell’80 prima dello scontro: contrattare il peggioramento della condizione lavorativa,
fino alla concertazione.
Concertazione
che oggi il padronato mette
in discussione da destra: dopo aver ottenuto risultati sociali ed
ideologici, tende a riproporre la pratica della decisione unilaterale, e
porta alla testa di Confindustria un uomo come D’Amato.
Di
fronte alla durezza dell’attacco padronale, cosa propone il sindacato?
Non
si vede traccia, in Italia, di una operazione come quella che, non il capo
di un sindacato eversivo, ma il numero uno del più grande sindacato degli
Stati Uniti, l’ Afl-Cio, ha messo in campo,
proponendo una discontinuità radicale con la storia del
sindacalismo americano recente.
E,
infatti, a Seattle loro c’erano, invece a Praga i sindacati europei non
si sono visti.
Allora
credo anch’io, come Zipponi, che sia indispensabile una discontinuità
politica e culturale.
Di
quella politica non parlo, perché sono larghissimamente d’accordo
conlui, su quella culturale ho
dei dubbi.
Cito
due casi senza argomentare: il salario sociale e il rapporto tra legge e
contratto, due facce della stessa medaglia.
Quando
invoco una discontinuità, non penso ad un ritorno al passato, neppure a
quella che considero la più grande esperienza del sindacalismo italiano:
il sindacato dei consigli, assolutamente irricostruibile in una realtà
come l’odierna.
Ma
se è così, allora abbiamo il problema di un soggetto, di una soggettività
di classe, e di forme di
ricomposizione del blocco sociale di riferimento e di organizzazione, che
devono essere reindagate.
Non
credo che una operazione come questa possa eludere il tema della
disoccupazione di massa e strutturale e del salario sociale (il reddito di
cittadinanza è un’altra cosa), come forzatura verso la trasformazione
del lavoro precario in lavoro più stabile e la costruzione di forme di
lavoro organizzato.
Non
si capisce per quale ragione i trasferimenti dallo stato possono andare
solo all'impresa e non, invece, a quelli cui l’impresa sottrae la
possibilità di essere al lavoro.
La
legge. Non è possibile ricostruire l’unità delle popolazioni
lavorative disperse senza una legge che introduca uno statuto dei diritti
dei lavoratori esteso ai precari, ai disoccupati, ai cosiddetti autonomi
di ultima generazione, come ordinamento di diritti.
La
contrattazione aveva un punto di forza gigantesco in una soggettività che
era vocata a costruirsi unità
e forza concentrata.
Il
quinto congresso della Cgil compì una svolta radicale, dall’idea della
contrattazione centralizzata all’idea
della contrattazione articolata. Solo perché avevamo perso alla
Fiat negli anni cinquanta, o forse perché avevamo indagato diversamente
la riorganizzazione del processo produttivo in Italia? Soprattutto per la
seconda ragione.
Oggi,
è pensabile fare tutto con il contratto, oppure è necessario ritrovare
una leva di riorganizzazione?
Sbaglia
Zipponi quando mette sullo stesso piano chi ha rivendicato la riduzione
dell’orario di lavoro con la legge e chi sosteneva che andasse fatta
solo con il contratto: l’orario di lavoro è aumentato. E , fino a
quando si è invocata la necessità della legge, bene o male si è
discusso dell’orario di lavoro, poi il tema è scomparso.
Allora
non si può più giocare, come mi avevano insegnato i miei padri al
sindacato, la contrapposizione tra contratto e legge, tra la grande
esperienza italiana del contratto e l’esperienza, un po’ elementare,
dei francesi. Forse dobbiamo pensare ad una ricostruzione politico
culturale adeguata a questo passaggio.
Ultima
questione, quella politica, trattata nella parte finale del libro: il
compromesso.
Sarei
d’accordo con la
ricostruzione di un compromesso dinamico tra le classi che tenda ad
introdurre un protagonismo diverso dell’Europa nel mondo, nelle
relazioni internazionali, nel rapporto tra nord e sud ed anche come
possibilità di costruire elementi di un modello di sviluppo non
direttamente ricalcato dalla globalizzazione.
Ma
c’è un problema: questo compromesso, in che rapporto sta con il
processo di modernizzazione capitalistico in corso? Sta nelle sue corde
oppure no? La mia opinione è che non stia nelle sue corde e che siamo in
una fase di regressione di civiltà provocata dalla modernizzazione
capitalistica.
I
neopopulismi che insorgono (quello razziale, quello religioso, quello
ideologico) sono in parte una reazione, ma dialetticamente entrano a
formare questo processo.
Questo
liberismo non è liberale, Zipponi. A parte il fatto che i due termini,
non solo non sono la stessa cosa, ma non è detto nemmeno che stiano
insieme.
A
proposito di terze vie, Benedetto Croce, che qualche importanza nel
pensiero liberale l’ha avuta, scrive nel ’44: per affermare il
pensiero liberale bisogna che ci si liberi del liberismo. Croce immaginava
che potesse esistere un pensiero liberale senza liberismo.
Oggi
le forze egemoni pensano ad un assetto neoliberista, senza alcunchè di
liberale, che si combina, anzi, con un pensiero neopopulista e
sostanzialmente ademocratico.
Tutto
ciò che riguarda l’Europa è iscritto in questi termini e si fa
evidente nel confronto tra la Costituzione Italiana e la Carta europea dei
diritti: la prima è una costruzione progressista, l’altra
è una carta fintamente liberale, in cui persino il diritto di
sciopero viene marginalizzato, mentre i diritti esigibili proprio non ci
sono.
Un
passaggio, come quello indicato nella Costituzione Italiana, secondo cui
la Repubblica deve intervenire per rimuovere le cause che ostacolano il
libero sviluppo della personalità umana, viene considerato satanico
comunismo.
Come
conciliamo il compromesso dinamico con questa tendenza del capitalismo?
Non sarà che, senza essere troppo sbrigativi,
forse bisogna mettere all’ordine del giorno la critica, la
contestazione, il superamento del capitalismo? E non sarà che anche il
potere contrattuale è cresciuto quando c’era una forza antagonista (in
senso di critica al capitalismo) sul terreno delle culture , delle
ideologie, delle prassi politiche? E non sarà che quel compromesso che si
realizzò nell’Europa e nell’Italia degli anni ‘50, ‘60, ‘70
fu possibile perché (lo dico senza alcuna nostalgia) c’era l’
URSS, e c’era la lotta di classe?
Se
non ci fossero stati questi due elementi, il campo dell’Est e la lotta
di classe in Europa, quel compromesso non ci sarebbe stato.
Se
è così, allora, parliamo pure di compromesso, ma quali sono le potenze
che entrano in campo per poterlo realizzare? Questa è una domanda, credo,
non più eludibile.
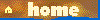

Mario
Agostinelli
Vorrei
concentrare le mie riflessioni su una osservazione, contenuta nel libro,
tutto sommato in forte controtendenza rispetto alle valutazioni che a
sinistra si danno anche oggi del ruolo, soprattutto del ruolo in politica,
del sindacato e della Cgil.
Zipponi
chiede se non sia vero che le difficoltà della sinistra derivino anche
dal fatto che il sindacato, e la Cgil in particolare, non sono più a
sufficienza terminali di conoscenza sui luoghi di lavoro.
E’
una domanda insolita, che non solo sento di dover indagare, ma che credo
debba meritare una risposta molto attenta anche per le vicende di fronte a
cui oggi si trova la Cgil.
Del
rapporto tra la produzione e la riproduzione sociale oggi si occupa
l’impresa, mentre assistiamo
ad una assenza impressionante della politica. Lo stesso sindacato, pur
arretrando nella rappresentanza del lavoro, ha finito per sostituire in
parte la politica su questo terreno.
Sta
qui la novità, ed anche l’anomalia, dell’attuale fase della vita
politica e sindacale italiana.
Anomalia
che produce un doppio effetto: la funzione,
anche tra le lavoratrici ed i lavoratori iscritti, di un il sindacato
“sovraesposto” in politica è quella di argine visibile rispetto alle
derive che in tema di diritti sociali vengono praticate. Si riconosce, ad
esempio, al segretario generale della Cgil il ruolo politico di essere
argine sicuro rispetto allo sfondamento.
Ma
mentre aumentano i rischi per l’autonomia del sindacato, con questa
sostituzione di campo (da sociale a politico) si allontana la definizione
di quel compromesso sociale, a mio giudizio indispensabile perché
l’azione dei sindacato a difesa dei diritti dei lavoratori sia
sufficiente ed efficace.
Mi
sembra (Zipponi pone questa domanda e poi dà anche delle risposte) che
uno degli ostacoli ad una ripresa della sinistra sta nel fatto che la
rappresentanza del suo sindacato nel mondo del
lavoro si è fortemente affievolita. Quindi dobbiamo partire
dall’analisi di una sconfitta subita anche dal sindacato.
Perché
ho voluto fare questa premessa? Perché sono ormai convinto, e in questo
senso mi discosto un po’ dalle interpretazioni di chi è intervenuto
qui, che tutte le organizzazioni, sindacato compreso, così come sono oggi
non riescono a cogliere fino in fondo quanto sta avvenendo.
Credo
che la democratizzazione, e la riscoperta della sovranità dei lavoratori,
degli iscritti, dei rappresentati, dentro le organizzazioni, compresa
quella sindacale, sia il problema più grande che abbiamo di fronte.
Cosa
contano gli iscritti della Cgil di fronte al Congresso? Così come: quanto
contano, ad esempio, gli iscritti ai partiti, o cosa contano i cittadini
rispetto alle amministrazioni? Questa questione,
nel sindacato è assolutamente non sufficientemente all’ordine
del giorno.
Per
questo non mi convince l’idea che il prossimo Congresso della Cgil, che
sarà una grande prova, magari anche democratica perché si vota, si
trasformi in una prova elettorale tra i lavoratori chiamati a scegliere su
documenti che sono espressione di posizioni tutte interne agli apparati.
Questa modalità non è adeguata alle cose che, anche qui, sono state
dette qui. Sono estremamente determinato, ma probabilmente non riusciremo
a misurarci su questo nodo.
Finiremo
per fare dell’occasione più grande che abbiamo davanti (in questo senso
il libro mi interessa molto), in cui, potenzialmente, si sentono tutti i
cinque milioni di iscritti e pensionati, un momento in cui l’ascolto e
il diritto di proposta di quegli iscritti non si attua, non si realizza. E
dove, tutto sommato, l’appartenenza a culture e posizioni politiche
dell’apparato fa velo della possibilità di misurarsi con cosa è
cambiato all’interno del mondo del lavoro.
Per
la mia cultura e storia, tengo moltissime assemblee nei luoghi di lavoro,
come Zipponi, e sento che questa “ricetta” non è in grado di dare
risposta alla gran parte dei problemi che vengono posti a partire dalle
condizioni lavorative.
Faccio
degli esempi. Abbiamo continuato a lavorare sui processi di
esternalizzazione come se si andasse da luoghi dove noi avevamo presidi e
che venivano ristrutturati, cioè
da grandi imprese, verso imprese piccole, disperse e non più
riconducibili a qualche ragione di aggregazione. Non è così.
Oggi,
in Lombardia, le imprese più
grandi sono imprese di outsourcing e di servizi.
Le
imprese di che forniscono servizi per le mense o le imprese di
manutenzione hanno cinquemila, seimila dipendenti, con una differenza
rispetto a prima: mentre nei luoghi di partenza c’era un solo contratto
di lavoro a tempo indeterminato con pienezza diritti, nelle grandi
imprese, dove si ricoagula il processo di esternalizzazione non c’è
controllo dell’orario, non ci sono diritti, sono presenti dodici, quindici e
più contratti diversi.
O
cogliamo che c’è un problema di ricostruzione del ciclo della
rappresentanza, oppure la semplice appartenenza degli apparati ad una
analisi e ad una posizione di maggioranza o di minoranza in Cgil non basta
più.
Eppure
finiremo lì, finiremo con il perdere una occasione straordinaria,
finiremo con il rinunciare, uso un parola forte, alla sovranità dentro il
sindacato di quelli che ricorrono al sindacato.
C’è
una parte del libro di Zipponi, che andrebbe diffusa e letta, che parla di
qualcosa di molto lombardo.
Nella
nostra regione la forza del movimento operaio è stata quella di non
rinunciare mai a governare il cambiamento nel lavoro “standoci
dentro”.
Zipponi
parla di quattro, cinque assemblee che occupano lo spazio del libro:
l’Ansaldo è il lavoro decotto che viene riqualificato; l’esperienza
della Abb è quella invece del lavoro professionale e qualificato che deve
essere mantenuto nel contesto della competizione; il telelavoro è la
trasformazione profonda del contesto temporale e spaziale dell’impiego.
Nelle
nostre lotte, di cui parla Zipponi, abbiamo registrato successi e
sconfitte, ma non perché da una parte c’era una linea buona e
dall’altra una linea cattiva.
Perché,
invece e purtroppo, la sconfitta, che pagano tutti e dalla quale, magari,
non si esce più come prima, non è stata causata solo da un passaggio
sbagliato nei gruppi dirigenti, ma si è realizzata perché nel conflitto
di classe o la sconfitta viene riposizionata su un versante di
ricomposizione adatto per ritornare a combattere, oppure l’unico esito
è quello di dividerci ulteriormente.
Alle
sconfitte abbiamo sempre risposto ricostruendo il terreno da cui
ripartire.
Il
problema che abbiamo oggi, e il libro lo dice, è che nella maggior parte
dei casi non siamo in grado di ricostruire
quel terreno.
La
Falck di Sesto San Giovanni, ad esempio, non è stata una confitta: oggi lì
abbiamo ricostruito condizioni ed un terreno di governo della
trasformazione del lavoro per cui lo stesso rapporto con l’istituzione,
con la cittadinanza, con l’insieme dei lavoratori del territorio, con i
giovani in cerca di occupazione, crea le premesse per una prospettiva di
successo. La stessa cosa è avvenuta all’Olivetti di Crema.
Altrove,
anche qui in Lombardia, siamo stati, viceversa, incapaci di questa
prospettiva: ad Arese, ad esempio.
In
alcuni casi, per nostra fortuna, tra noi ed i lavoratori non c’è stato
un addio; nell’ultima assemblea all’ Olivetti di Crema, con mille e
venti lavoratori che concludevano la loro vita dentro la fabbrica,
ricordo l’intervento di un lavoratore che diceva: non è un
addio, torniamo a combattere, a lottare, anche altrove.
Ma
nella gran parte dei casi, analoghe vicende si sono concluse con un addio,
con una chiusura della partita, senza i volti del lavoro in campo. La Fiat
vale per tutti.
Zipponi
scopre, come filo conduttore dei conflitti, il grande tema del tempo. Sono
convinto abbia ragione.
Sono
cresciuto in una fase in cui il modello di lavoro entro cui le nostre
lotte si strutturavano, per poter autonomamente conquistare potere, era
quello che aveva dato vita ai consigli: i reparti strutturati con una
sequenza, con una finalità riconosciuta, con un filo autonomamente
dipanato.
Oggi
le rappresentanze e le loro articolazioni nell’organizzazione del lavoro
non si ricompongono più soltanto nello spazio della fabbrica e degli
uffici, che non esiste più come lo conoscevamo, ma nel tempo, e questo è
terreno ancora da esplorare.
Qui
si colloca la proposta di Zipponi, di cui ancora non si è parlato in
questo dibattito, ma che considero fondamentale.
Nel
patto taylorista la ripartizione della giornata – otto ore di lavoro,
otto di riposo, otto di tempo libero – era l’oggetto di
rivendicazione. Adesso è la ripartizione del tempo sulla settimana la
leva di cambiamento per una riappropriazione ed un autogoverno del tempo
di vita e di lavoro.
Quattro
giorni di lavoro, due di riposo, uno di formazione è la ricetta che il
libro fornisce. Cerchiamone tutte le implicazioni e vedremo quanto è
innovativa, quanto conflittualmente “moderna”.
Ad
esempio, qui in Lombardia, sulla formazione c’è uno scontro molto alto:
viene privatizzata dalla Regione, non è retribuita dalle aziende, è
addirittura falsificata nei rapporti di apprendistato, è finalizzata solo
all’impresa e sottratta all’interesse più generale che aveva dato
vita all’esperienza straordinaria delle 150 ore.
Nel
contesto sociale in cui viviamo, i due giorni di riposo che altro sono, se
non lo spazio per l’industrializzazione dell’offerta del tempo libero
e per la commercializzazione persino della parte dell’esistenza che non
è stata occupata dalla prestazione lavorativa?
Credo
che il compromesso sociale che dobbiamo conquistare debba passare dalla
discussione e dalla decisione sul governo del tempo, naturalmente con
precisi riferimenti alla natura del lavoro ed ai rapporti di produzione.
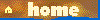 
Maurizio
Zipponi
Non
è il mio mestiere scrivere libri. Ho accettato di farlo per affermare
l'esigenza, che non è solo mia ma dei molti con cui mi ritrovo
quotidianamente a discutere, di non accettare come scontato e
irreversibile che sul piano politico
comunque si perderà e la destra governerà il paese e che sul
piano sociale i lavoratori non possono avere una rappresentanza sindacale
generale, democratica diversa dalla attuale.
E
allora è indispensabile porsi e rispondere ad una domanda: i lavoratori,
non entità astratta ma persone in carne ed ossa, che con un milione e
mezzo al mese devono pagare un affitto o un mutuo, mandare a scuola i
propri figli, far quadrare i conti, a vent’anni dall'inizio dei processi
di ristrutturazione, stanno meglio oppure
peggio?
Chi
lavora, oggi, sta peggio.
Perché si è ridotto il potere d'acquisto del suo salario ma,
soprattutto, perché si sente solo, impotente rispetto alla possibilità
di cambiare insieme ad altri la propria condizione.
E
sulla constatazione dell'oggettivo peggioramento della situazione del
lavoratore si inserisce l'ideologica, pervasiva teoria (con cui veniamo da
un po' di tempo bombardati) secondo la quale: certo che gli uomini e le
donne che ogni mattina si recano nelle fabbriche e negli uffici stanno
peggio; non potrebbe essere diversamente, dal momento che stanno
scomparendo per essere sostituti da figure professionali diverse e più
"moderne",; dal momento che il lavoro tradizionalmente sfruttato
non è che un residuo del passato, che i nuovi lavori sono, e sempre più
saranno, autonomi, coinvolgenti, gratificanti.
Ma
cosa scompare, e, soprattutto, con cosa il lavoro dipendente viene
sostituito?
Scompaiono
le parole del nostro vocabolario, rimpiazzate da moderni termini inglesi:
indicano le stesse cose, ma sono meno chiari, a volte incomprensibili,
incutono timore, disarmano; appaiono come il futuro mentre propongono il
più retrivo passato.
Tutti
imprenditori di noi stessi, allora?
Ma
cosa viene proposto, oggi, ad un giovane? Ti assumiamo con un contratto di
collaborazione, così sei autonomo. Anzi, facciamo come dice Bossi: ti
diamo i soldi in mano, tutti, poi ti
devi pagare i contributi, le tasse, li prendi per undici mesi e non per
dodici, non hai le ferie, la maternità, non ti puoi ammalare; sei
imprenditore di te stesso nel senso che con i soldi che ti abbiamo
consegnato non hai alcuna protezione.
Questa
condizione di lavoro, che sta sostituendo quella tradizionale, rende
migliore l'esistenza degli uomini e delle donne? La solitudine, è una
conquista di progresso? La precarietà, è un elemento rasserenante, che
aiuta nella costruzione del futuro?
No,
no, no. Non lo penso solo io, lo dicono le lavoratrici ed i lavoratori.
Basta ascoltarli.
Proprio
per questa ragione, io chiedo ai compagni seduti a questo tavolo e a chi
stasera è qui: è possibile la ricostruzione di una dialettica? Non
discuto del numero delle sinistre, è vero, sono tante, e oggi il pensare
di ricomporle sulla base delle appartenenze non è una ipotesi immediata e
perseguibile. Ma penso (e non credo sia stupido ottimismo) che se la
sinistra italiana, moderata o radicale che sia, ricostruisse la catena del
lavoro – comincia con
un'idea, poi l’idea diventa progetto, il progetto diventa merce, la
merce viene venduta e poi acquistata - e su quella
misurasse una rappresentanza del lavoro
e dei lavoratori, si potrebbero trovare punti di piattaforma
comune.
Rassegnarsi
all’attuale situazione è un errore: siamo in una fase di transizione,
le modifiche del lavoro e dell’impresa ci dicono che possiamo
intervenire con piattaforme, rivendicazioni e conflitto.
Certo,
il sindacato è uno snodo fondamentale in questa discussione.
La
Cgil ha sottovaluto, o non vuole ammettere, la crisi profonda che la sta
attraversando, tanto che chi tenta di ragionare su questo terreno viene
considerato visionario.
Eppure
io sento che il sindacato è fuori dalle stanze dove si decide quali le
merci e servizi vengono prodotti, come vengono prodotti,
quali sono l’organizzazione e la divisione del lavoro, ed è
fuori anche dai punti di sapere fondamentali.
E
quando un sindacato non ha accesso ai momenti in cui si decide davvero, e
l’unico ruolo riconosciuto
è quello istituzionale, è evidente che è un sindacato in crisi, non
fosse altro perché è in balia dei mutamenti della situazione politica.
Quando
un sindacato lega la sua linea e la sua azione ad un governo o ad un
partito (di opposizione o di governo) consegna la propria autonomia al
quadro politico ed alla logica dell’impresa. E questo è un errore
letale.
Il
sindacato e il rapporto con i lavoratori.
E’
stato da poco siglato un accordo nel settore della telecomunicazioni.
Porta la firma di un segretario nazionale della Cgil. E' stato sottoposto
a referendum tra i lavoratori. I lavoratori lo hanno respinto. L’accordo
vale.
Allora
c’è un nodo che viene prima del conflitto e del cosa rivendicare: è il
patto di fiducia tra i lavoratori e il loro sindacato che va ricostruito.
Perché
se nello statuto di un sindacato c’è scritto che gli accordi valgono
quando i lavoratori hanno votato, ma quel voto vale solo se i lavoratori
dicono “sì”, non siamo di fronte ad
un grande criterio democratico.
E
allora dobbiamo metterci nella condizione di dire che con i lavoratori si
ricostruisce una piattaforma su tre questioni fondamentali: salario,
garanzie e tempo. Una piattaforma chiara, con alla base un principio
democratico, in modo da dire ai lavoratori: facciamo un patto, abbiamo una
piattaforma, avviamo la lotta per sostenerla e io, sindacato, firmo il
contratto, l’accordo solo se tu, lavoratore, lo approvi.
O
su questi nodi il sindacato cambia, introduce una forte discontinuità con
il passato, oppure il problema non sarà tra maggioranza e minoranza in
Cgil.: la C.G.I.L. entrerà
in un crisi irreversibile.
Mentre
la Cisl può sopravvivere dentro una deriva corporativa, la Cgil senza una
piattaforma, senza una autonomia vera, fortissima, senza una
sburocratizzazione, senza una corrispondenza del suo gruppo dirigente tra
il dire e il fare, rischia se stessa.
Anche
perché agli imprenditori, anche oggi, non fa comodo avere un sindacato
confederale come la Cgil.
Termino
sul punto del mio ragionamento su cui Bertinotti ha avanzato delle
perplessità. Non penso che le imprese soffrano l’assenza del conflitto.
Ma
sento che le imprese e le loro associazioni hanno un punto critico: se
l’impresa italiana e il sistema paese concorre sul basso costo del
lavoro e sulla riduzione delle libertà dei lavoratori, è lì che vengono
indirizzati investimenti e la ricerca, cioè è lì che viene indirizzata
l’impresa. E, non il sistema, ma l’impresa che guadagna, perché paga
poco i propri lavoratori non ha prospettive sul medio e lungo periodo:
oggi, per effetto della globalizzazione, un imprenditore, o si pone
l’obiettivo di portare il salario di un metalmeccanico italiano a
trecentocinquantamila lire al mese, e allora regge la concorrenza con i
prodotti indiani, oppure, se
non ci riesce, viene buttato fuori dal mercato.
Allora
non sostengo che le imprese si augurino il conflitto, vado più in là:
dico che un conflitto sul salario che costringa
l’imprenditore a cercare prodotti ad alta qualità che competano
su un mercato non a basso costo, non è nell’interesse del singolo
imprenditore, che ovviamente preferisce la strada breve del pagare poco,
ma è nell’interesse anche del sistema delle imprese.
La
tendenza a ridurre stato sociale e salari, ad un certo punto mette a
rischio anche l’equilibrio democratico di un paese.
Recentemente,
seppure in modo meno vistoso che in altri paesi, abbiamo assistito alla
ripresa del terrorismo.
Elezioni
politiche, vertenza Fiat, contratto dei metalmeccanici e della scuola:
qualora si aprissero conflitti sul salario, sulla libertà, sul tempo,
iniziassero gli scioperi in Fiat, gli scioperi nei settore metalmeccanico
e pubblico, le azioni terroristiche potrebbero essere usate come elemento
destabilizzante. I proclami rinvenuti nelle fabbriche e le azioni
dimostrative a Milano, sono
segnali da non sottovalutare.
Ho
deciso, nel libro, di riportare storie di lotte operaie al termine delle
quali i lavoratori hanno ottenuto dei risultati, non per dire: guardate
come è facile vincere, ma per affermare che non è obbligatorio uscire
sconfitti.
“Ci
siamo!”, quindi, fisicamente e produciamo la ricchezza di questo paese;
possiamo (la situazione economica oggi permette la ripresa del
conflitto attorno ad una piattaforma) anche vincere.
Ad una condizione: non rassegnarsi.
E
a non rassegnarmi mi hanno convinto i lavoratori e le lavoratrici
durante le assemblee; me l’hanno insegnato le cinquecento donne
della Marelli, che per mesi si sono opposte alla Fiat ed alla fine sono
riuscite a “spuntare” condizioni diverse e migliori rispetto a quelle
di altre aziende su un nodo fondamentale come il tempo.
Queste
esperienze mi portano a pensare che ci sia un grande lavoro da fare: avere
ambizioni più alte; non dare
per scontata la vittoria di Berlusconi e l’annullamento dello stato
sociale; non considerare irreversibile la crisi del sindacato e la
frantumazione della rappresentanza del mondo del lavoro.
Ma
nulla è già scritto: perché le generazioni che ci hanno preceduto erano
in condizioni di vita, di libertà peggiori delle nostre; perché chi ha
fatto gli anni ’50 stava peggio, i nostri padri stavano peggio, eppure
sono riusciti a darci la possibilità
di stare meglio.
I
soggetti in campo sono due, non uno: c’è Confindustria, ma anche i
lavoratori. A loro dobbiamo dare voce sul piano politico e sul piano
sociale. Per farlo dobbiamo riformare il sindacato, ed i partiti politici
della sinistra devono capire che viviamo una fase di transizione e che è
necessario avere ambizioni ben più alte.
Questo
è il messaggio del libro e la discussione che vorrei si aprisse.
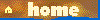

Rossana
Rossanda
Condivido
quello che ha detto Zipponi: viviamo in una fase di crisi profonda della
cultura, del senso di sé; ci sentiamo soli e siamo persuasi che ciò che
ci differenzia dai nostri padri è la loro convinzione che si potesse
lottare, mentre oggi il dubbio è che non ci sia più nulla da fare.
"Si
può, se si vuole e si ha la forza di rompere l’isolamento": questo
è il messaggio forte da inviare.
Non
è semplice. Non solo c'è
stata una sconfitta sul terreno economico, ma una sorta di atomizzazione
delle persone, dei valori, del rapporto: è come se tutto si fosse
frammentato senza portare a una maggiore ricomposizione.
Detto
questo, voglio soffermarmi su due aspetti.
Il
primo. Capisco poco, forse perché sono estranea al sindacato, la
discussione in corso tra Zipponi e Agostinelli.
Se
si ammette che le cose vanno sempre peggio, allora non è vero che non
c’è niente da perdere fuori che le proprie catene, perché
nell’ipotesi del padronato italiano c’è
non solo il progressivo svuotamento interno della Cgil, ma c’è
la sua liquidazione.
Per
quanto in crisi la Cgil c’è
ancora, è l’ultimo presidio più di
quanto non lo sia la politica (su questo Agostinelli ha ragione).
Ma,
oggi, chi fa vita politica? Non la gente nei grandi partiti istituzionali,
e neanche i parlamentari.
Il
dire “c’è ancora qualcosa da perdere”, però,
non è una buona ragione – mi permetto di dire all’amico
Agostinelli - per non vedere gli elementi di crisi profonda iscritti sia
nell’aggressione capitalistica che viene sferrata, che all’interno del
sindacato confederale.
La
crisi profonda della sinistra e del sindacato va riconosciuta.
E,
soprattutto, io che sono convinta che la mancanza di democrazia sia
elemento comune della crisi di partiti e sindacato, sono certa che questa
crisi di democrazia, questa mancanza di ascolto sia tanto più grave in un
congresso che, come quello della Cgil, viene fatto nelle fabbriche, nei
luoghi di lavoro.
Non
mi dite che un’ora di lavoro per presentare piattaforme è un travaglio
democratico reale di un congresso! Una volta, anche in una breve
assemblea, c’era un senso comune condiviso, adesso questo non c’è più.
Così
come penso sia un fatto non democratico, e un segno di mancanza di
autonomia, che la Cgil rimandi il suo congresso dopo le elezioni
legislative.
La
Cgil potrebbe svolgere il suo congresso, dovrebbe farlo, e semmai, dopo le
elezioni aggiusterà il tiro.
Il
fare un serio congresso adesso sarebbe stato un modo per partecipare alla
ricostruzione di una volontà di sinistra nel paese.
Siamo di fronte ad una aggressione più violenta di quella che
sferrarono dopo il ’48. Allora ci dicevano “siete cattivi”, oggi ci
dicono "non siete": per questo Zipponi
afferma “Ci siamo!”.
La
lotta contro questa egemonia culturale si fa sul piano sindacale e sul
terreno politico e culturale, non c’è un prima e un dopo, e comporta
scelte sulle quali si gioca anche la questione della sinistra.
Ci
ripetono che bisogna stare all’interno dell’innovazione del capitale.
E allora io chiedo: in cosa consiste l’innovazione del capitale?
All'inizio
del secolo scorso, le ferrovie sono state un elemento di globalizzazione
del capitale; oggi la velocità di movimento del capitale urta contro la
materialità immobile dei corpi dei lavoratori. Qui stà l'innovazione
profonda nei rapporti di forza. Assistiamo a grandi trasformazioni
organizzative nell’impresa: diventano enormi, addirittura pletoriche,
aziende che non sono più il corpo produttivo, ma un sistema
di servizi a basso profilo.
Insisto:
in questi processi di innovazione organizzativa e tecnologica c’è una
grande vittoria del principio di unificazione culturale, su scala
mondiale, delle ragioni dell’economia capitalistica, del capitale più
che dell’impresa.
Sento
parlare sempre di “impresa”, ma le imprese cambiano ogni cinque
minuti, hanno una tale velocità di fusione, trasformazione, cambiamento
che impressiona. C’è una grande crescita del capitale che, come sempre,
travolge il lavoratore ed anche la singolarità dell’impresa e del suo
processo di riproduzione.
Allora
bisogna tenere presente che l’innovazione non toglie di mezzo la natura
del capitale; è su questo che le sinistre non sono d'accordo.
La
sinistra europea, mediamente, pensa
che l'unica legge sia quella dell’economia, che sia il capitalismo il
motore dello sviluppo. Rispetto a questo pensa fossero sbagliate, anche
economicamente, le idee di una conflittualità tra capitale e lavoro, non
parliamo poi dell’idea di una società non fondata sul capitale.
E’
questo che divide le sinistre; da questo poi discendono altre scelte su
terreni come la scuola, la sanità, ecc.
Zipponi
sostiene che sarebbe fondamentale trovare a sinistra una posizione comune
sulla necessità di ripartire dal lavoro: questo, però, significa
ammettere che il lavoro non
è funzione del capitale, è un principio che noi scegliamo, non perché
sia una verità teologica, ma perchè è una verità della modernità, è
una verità recente. Infatti il mondo è vissuto tre milioni di anni senza
che il lavoro avesse questi diritti, questo statuto. Il primo a dire che
il lavoro non è funzione dell’impresa è stato Marx, interpretando la
Rivoluzione Francese, poi è diventato senso comune con la fine della
Seconda Guerra mondiale, nel 1945, in quello che è stato il periodo
keynesiano.
Oggi
il senso comune è retrocesso, quando sia parla di innovazione dei
processi e per quanto riguarda lo sviluppo dell’economia e dei rapporti
di lavoro, in una posizione conservatrice perché torniamo ad una idea
liberista, che risale alla fine dell'ottocento, secondo cui il lavoro non
ha diritti.
Qui
però c’è una scelta politica, di coscienza, etica da compiere su
grandi temi, altrimenti siamo "progressisti" nel senso che ciò
che è nuovo va bene. Ma dove sta scritto? Penso che molte delle cose
nuove non vanno bene affatto.
Ad
esempio, il sostenere che dal mercato dipende tutto non va bene, perché
poi ci sono i rapporti tra le persone, tra le culture; penso che abbiamo
alzato il livello dei consumi ma siamo, in un processo regressivo.
Così
come esistono regressi nella vita di una persona, che entra in
depressione, che sta male, anche una società può entrare in depressione,
stare male.
Su
questo dobbiamo capirci, per decidere che tipo di lotta portare avanti e
cosa intendiamo per sinistra.
Altro
punto, che fa parte della
riflessione sull’egemonia.
L’ho
detto prima, non è vero che lo Stato, il bene pubblico corrispondono al
bene dell’impresa. E, aggiungo, il bene pubblico non corrisponde nemmeno
alla crescita della ricchezza.
Perché,
lo ricordava Salvi, di cui apprezzo il lavoro e la posizione, come
misuriamo la ricchezza?
Cosa
significa questa crescita della ricchezza quando gli abitanti della terra,
dall’inizio del secolo ad oggi, sono passati da uno a sette miliardi?
Non sono una negatrice dello sviluppo, ma si va verso forme di
omologazione psicologica, culturale e persino corporea e dei consumi che
non credo rappresentino un arricchimento dei singoli individui.
La
solitudine di cui parlava Zipponi deriva anche dal fatto che ci sono forme
di impoverimento interiore, culturale, di senso di sé, legate a questo
processo.
Di
questo dovremmo parlare, anche il sindacato deve parlare, perché se si
occupa dei beni e delle ricchezze, deve sapere che queste non sono solo il
salario.
Ultima
cosa. Propongo di togliere di mezzo la parola compromesso.
Penso
che i rapporti tra capitale e lavoro non abbiano mai la natura del patto
sociale, ma, sempre, la natura di uno scontro, perché hanno due finalità
diverse.
Il
rapporto di forza, di lotta, il no che si dice, non soltanto in fabbrica,
ha portato via via, dopo la prima guerra mondiale,
il sistema capitalistico ottocentesco a cedere su alcune posizioni.
Tra
la prima e la seconda guerra mondiale una parte dei paesi capitalistici si
è indirizzata verso il fascismo, l’altra ha scoperto quello che adesso
chiamiamo il compromesso sociale, cioè il keynesismo, che non era, però,
una visione ideologica delle cose, ma una constatazione dei
rapporti di forza.
Togliamoci
dalla testa l' idea che, ad un certo punto, i lavoratori avrebbero potuto
fare la rivoluzione, invece hanno scelto il compromesso. Ogni diritto è
stato conquistato con uno scontro e un rapporto di forza; scontro e
rapporto di forza connaturati nell’umana natura, anche tra uomini e
donne.
Allora
non usiamo il termine "compromesso" e parliamo di rapporto di
forza.
Il
rapporto di forze moderno, capitalistico - Marx l’aveva detto - riguarda
il possessore dei mezzi di produzione e chi non li ha, cioè l’immensa
maggioranza del mondo, e si attua attraverso una pressione reciproca.
Il
capitale si sta riprendendo tutto quello che aveva perso, non attraverso
la proposta di un altro patto sociale, ma facendo una guerra nel senso
moderno e avanzato della parola.
Il
problema è come il lavoro può organizzare la sua forza, i suoi bisogni e
la sua idea di società, all’interno di un dominio capitalistico senza
più i due campi nei quali si erano identificati il campo del lavoro e
quello del capitale.
Vogliamo
parlare, per una volta, di questa storia in modo non puramente
manicheistico e formale?
Stiamo
di fronte ad una contraddizione reale tra capitale e non capitale, in un
momento di grande forza e riorganizzazione capitalistica e abbiamo il
problema della ricomposizione dei non capitalisti.
Questo
problema ha dietro di sé una idea del valore dell’uomo e della donna,
della loro indisponibilità; una capacità e voglia di organizzarsi; la
convinzione che la crescita delle disuguaglianze non è accettabile.
E
se riuscissimo a trovare su questo un terreno comune per l’insieme della
sinistra avremmo fatto un grandissimo passo avanti.
Se
riuscissimo a riconoscere che oggi, mediamente, il tenore di vita degli
americani e degli inglesi è quello del 1900, non quello del 2001,
capiremmo che alla crescita del bisogno di consumi non ha corrisposto
l'aumento di un bisogno di coscienza.
Io
sono per una scelta di campo: una ipotesi di società e di valore
dell’uomo sulla quale misurare, intelligentemente, cosa è oggi la
sinistra italiana, cosa è il sindacato, cosa potrebbe essere la Cgil, su
cosa si può ricomporre.
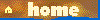 
|

